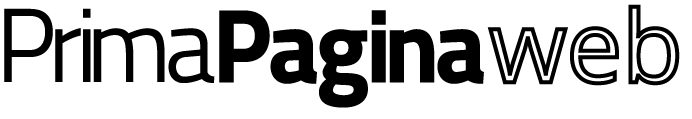di Giuseppe Lalli
La nebbia a gl’irti colli
piovigginando sale,
e sotto il maestrale
urla e biancheggia il mar;
ma per le vie del borgo
dal ribollir de’ tini
va l’aspro odor dei vini
l’anime a rallegrar.
Gira su’ ceppi accesi
lo spiedo scoppiettando:
sta il cacciator fischiando
sull’uscio a rimirar
tra le rossastre nubi,
stormi d’uccelli neri,
com’esuli pensieri,
nel vespero migrar.
- Carducci, 1883

Quelli che precedono sono i versi di una breve poesia di Giosuè Carducci (Valdicastello, 1835 – Bologna, 1907) intitolata San Martino, versi che nel secolo scorso generazioni di bambini italiani hanno imparato a memoria negli anni delle scuole elementari. Trasuda da queste strofe un’atmosfera di dolce malinconia. Le parole sono altrettante pennellate di colori tenui, come in un quadro impressionista. Suoni, odori e sapori della vita semplice, paesana, come ce la raccontavano i nostri nonni e come l’abbiamo in parte respirata anche noi, ci sorprendono ad ogni riga.
Giosuè Carducci fu tante cose (scrittore, professore universitario, studioso erudito, politico), ma fu innanzitutto poeta della vita. «L’aspro odor dei vini» che si effonde «per le vie del borgo», per chi come lo scrivente ha assistito al tramonto di un’epoca, ha la stessa funzione che per Marcel Proust (1871–1922) aveva il profumo dell’acqua di colonia nella casa di campagna della nonna: un profluvio di ricordi che avvolge l’anima, uno stato di grazia che si pensava non si potesse rivivere.
«L’aspro odor dei vini» è la nota dominante di tutta la piccola lirica, è il motivo musicale che attraversa lo spazio e il tempo e si para davanti ai nostri sensi, insieme all’aria frizzante dei pomeriggi autunnali riscaldati dai «ceppi accesi» su cui girava «lo spiedo scoppiettando», espressione, quest’ultima, che riproduce fin dal suono delle parole il calore degli affetti della famiglia raccolta in semicerchio attorno al focolare, come ancora si usava al tempo dei nostri vecchi; mentre, sullo sfondo, l’immagine degli «stormi di uccelli neri» che «com’esuli pensieri, nel vespero migrar» il cacciatore sta rimirando «tra le rossastre nubi», induce a pensare che ogni cosa è destinata a sanarsi, nell’oblio, che niente può ferirci per sempre; e ciò inclina il cuore alla serenità e alla speranza.
Analogo sentimento si prova in altre liriche ispirate al poeta dal paesaggio che fece da cornice alla sua infanzia e alla sua prima giovinezza, quello della campagna toscana della Versilia, prima, e quello della Maremma dopo: figure e ricordi dai quali il Carducci maturo, disilluso dalla politica e provato dal dolore (si pensi a Pianto antico, scritto nel 1871 a poco tempo dalla morte del suo figlioletto), trae forza e coraggio. Ed ecco, in Il bove (1872), l’immagine rassicurante dei campi arati, che insieme alla fatica e al sudore dei contadini assume nel suo verso un che di sacro:
T’amo, o pio bove; e mite un sentimento
di vigore e di pace al cor m’infondi,
o che solenne come un monumento
tu guardi i campi liberi e fecondi,
o che inchinandoti al giogo contento
l’agil opra de l’uom grave secondi….
Ed ecco, in Traversando la Maremma toscana (1885),
…le nebbie sfumanti e il verde piano
ridente ne le piogge mattutine
di quelle colline familiari la cui vista infonde pace al cuore del poeta che, già avanti negli anni, le accarezza con lo sguardo trasognato e commosso (con gli occhi incerti tra ‘l sorriso e il pianto) da dietro il vetro del treno che da Bologna lo porta a Roma.
E che dire della freschezza e vivacità di colori, non disgiunte da una sottile leopardiana vena di rimpianto, che caratterizza un poesia come Idillio maremmano (1872)? Qui il ricordo della “bionda Maria” (giovane contadina conosciuta veramente e che si duole di non aver sposato) che incede tra i solchi in tutta l’opulenza delle sue forme giunoniche, è un gioioso inno alla vita e alla fecondità. L’immagine di questa ragazza, resa dal poeta così plastica, così viva, così desiderabile, parla ai sensi prima ancora che al cuore. E così, dopo aver rimarcato con carnale trasporto
…ché il fianco baldanzoso e il restìo
seno ai freni del vel promettean troppa
gioia d’amplessi al marital desìo ,
con pari ardore di passione, ma con più pacato accento lirico, il poeta prosegue:
Com’eri bella, o giovinetta, quando
tra l’ondeggiar de’ lunghi solchi uscivi
un tuo serto di fiori in man recando,
alta e ridente, e sotto i cigli vivi
di selvatico fuoco lampeggiante
grande e profondo l’occhio azzurro aprivi !
Ed ecco infine in Davanti San Guido (1874) il poeta che, già celebre e provato dalla vita, ritornando nei luoghi che lo videro bambino e rivedendo con occhi pieni di nostalgia

I cipressi che a Bólgheri alti e schietti
van da San Guido in duplice filar,
quasi in corsa giganti giovinetti…,
rimpiange la vita semplice che le immagini della natura gli evocano, e si duole con sé stesso per l’impossibilità di recuperare il tempo perduto.
È questo Carducci intimo e luminoso, romantico suo malgrado, che più ci attrae, al di là di quella scorza burbera di vecchio cinghiale maremmano che la sua immagine a prima vista ci trasmette. È un sentimentalismo, quello del Carducci, che convive con una robusta passione civile: è il poeta della piccola patria dell’infanzia – la Versilia e la Maremma, come si diceva – che tuttavia in lui non è mai angusto campanile, ma sempre premessa alla patria più grande, a quell’Italia che egli amò forsennatamente:
in faccia a lo stranier, che armato accampasi
su ’l nostro suol, cantate: Italia, Italia, Italia!
si legge nell’ode Saluto Italico, scritta nel 1879 in omaggio all’irredentismo triestino.
La poesia dell’autore delle Odi Barbare (1877) fu la colonna sonora di quell’Italia di fine Ottocento (l’Italia “umbertina”, come suol definirsi dagli storici) che oggi ci appare operosa e un po’ triste, pedagogica e decadente, moralista e anticlericale, e che tanta parte ebbe, in ogni caso, nella formazione di una coscienza nazionale.
Carducci fu uomo generoso con la vita, che pure gli riservò sofferenze, delusioni, gioie e angosce, come riserva a tutti, poeti e non poeti (si soffre tutti alla stessa maniera, chi più in alto, chi più in basso). In lui l’amore per la vita e per l’azione (si sa che fu posseduto dal dèmone della politica oltre che da quello della letteratura) non venne mai meno, né mai si abbandonò all’estetismo fine a sé stesso di tanti scrittori tardo–romantici o al paralizzante intimismo dei poeti decadenti, convinto che l’arte, anche quando è sublime, non può essere un modo per leccarsi le ferite, e la vita si cura con la vita stessa. La sua stessa erudizione aveva come fine ultimo quello di affinare lo strumento della sua creatività artistica, chiamata, a sua volta, a incidere sulla realtà.
Poeta della vita, dunque, il Carducci, che ci commuove e ci incoraggia pur con le sue contraddizioni e le sue umane fragilità, come quando, Alla stazione in una mattina d’autunno (1875), accompagna la donna amata (un rapporto sentimentale clandestino…) e, assistendo alla sua partenza, con la pioggia che sbatte sui vetri della locomotiva, ha l’impressione che tutto intorno l’atmosfera assuma i colori cupi e plumbei del suo stato d’animo, mentre il treno, definito «empio mostro», gli porta via, insieme alla donna, «gl’istanti gioiti e i ricordi».
Alla luce di questa convulsa vitalità (sono rimaste celebri le sue mangiate pantagrueliche e le sue bevute generose) va forse letto anche il suo trasformismo politico. È noto che il futuro premio Nobel per la letteratura rivide molte delle sue giovanili posizioni: da giacobino che era stato divenne conservatore, se non reazionario (s’invaghì del nazionalismo di Francesco Crispi (1818–1901); e da battagliero repubblicano si fece paladino della monarchia sabauda (si ricorda una sua ode alla regina Margherita, vibrante di…regale passione).
Non ci è dato di sapere se mutò la sua visione anche in tema di religione (chi può indagare tra le pieghe di un’anima?). Pure, la testimonianza di una sua giovane amica poetessa, a lui devota, getta un raggio di luce a tale riguardo. Il poeta, già maturo di anni e di arte, trovandosi nei primi mesi del 1891 in vacanza a Genova, si era recato a far visita al suo grande amico Giuseppe Verdi (1813–1901) a Palazzo Doria, dove il grande musicista stava finendo di comporre il Falstaff.
Verdi, chiamandomi – scrive l’amica che lo accompagnava – andò a sedere al suo pianoforte, e suonò – semplice e fluente come l’acqua che scorre – della dolce musica vagabonda. Ed era come se mi parlasse. Poi si alzò; e insieme uscimmo sul terrazzo, dove Carducci sedeva ancora guardando il mare. Ci ponemmo accanto e lui e per gran tempo nessuno parlò. Nel sole, sull’acqua danzante, le vele ondeggiavano lucenti e lievi, e passavano con inchini e riverenze verso l’azzurro lontano. Carducci a un tratto disse: – Io credo in Dio.
All’approssimarsi della vecchiaia, poi, egli, che in gioventù era stato autore di un Inno a Satana (1863), compose una commossa preghiera alla Madonna:
…Ave Maria! Quando sull’aure corre
l’umil saluto, i piccioli mortali
scovrono il capo, curvano la fronte
Dante ed Aroldo.
Una di flauti lenta melodia
passa invisibil fra la terra e il cielo:
spiriti forse che furon, che sono
e che saranno?
Un oblio lene de la faticosa
vita, un pensoso sospirar quïete,
una soave volontà di pianto
l’anime invade.
Taccion le fiere e gli uomini e le cose,
roseo ’l tramonto ne l’azzurro sfuma,
mormoran gli alti vertici ondeggianti
Ave Maria….
(da La chiesa di Polenta, 1897).
Nota al testo
- A. Vivanti, Giosuè Carducci, da Zingaresco, Milano, pp. 275-311, Mondadori 1931, in La letteratura italiana, Tomo III, Memorialisti dell’Ottocento, Carmelo Cappucci (a cura di), p. 670.