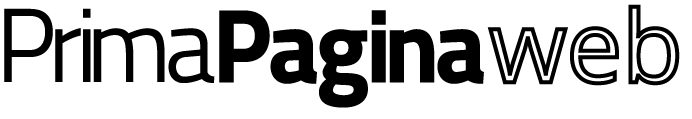di Giuseppe Lalli

Sì che Tu sei terribile!
Sì che in quei lini ascoso,
In braccio a quella Vergine,
Sovra quel sen pietoso,
Come da sopra i turbini
Regni, o Fanciul severo!
È fato il tuo pensiero,
È legge il tuo vagir.
Vedi le nostre lagrime,
Intendi i nostri gridi;
Il voler nostro interroghi,
E a tuo voler decidi;
Mentre a stornar la folgore
Trepido il prego ascende,
Sorda la folgor scende
Dove tu vuoi ferir.
…
Sono questi i primi versi di una poesia, Natale 1833 – poche e frammentarie strofe – che Alessandro Manzoni (1785–1873) scrisse nel primo anniversario della morte della moglie, Enrichetta Blondel (1791–1833). Lungi da me che scrivo l’idea di parafrasare questi versi. Rischierei di inserire note stonate in un concerto: la vera poesia è musica sacra, si può solo ascoltare. Rischierei di imbrattare un quadro: la poesia è tela dipinta con i colori dell’anima, si può solo contemplare.
Pure, non si può fare a meno di notare che in questi versi non c’è nulla di lezioso, né di ricercato. Non c’è nemmeno quell’atmosfera di solennità che si respira negli Inni sacri. Il tono stesso della poesia è tutt’altro che distaccato. Diciamo pure che è un grido di dolore quello che leggiamo, quasi una recriminazione. Dio, anche nelle forme di un bambino tra le mani pietose di sua madre, appare lontano, in un cielo muto e solcato da tremendi lampi, insensibile alle preghiere e ai lamenti («Sorda la folgor scende dove tu vuoi ferir»).
Il 25 dicembre 1833 al poeta era venuta a mancare la sua adorata moglie Enrichetta. Dio lo aveva visitato «terribilmente», come aveva scritto al Granduca di Toscana Leopoldo II (1797–1870), che aveva avuto nei confronti del già famoso scrittore parole di delicata partecipazione al suo dolore. Sposata in tenera età – aveva sedici anni – solerte e silenziosa, religiosissima, madre di numerosa prole, ciò che a lungo andare aveva finito per fiaccare la sua già delicata complessione, Enrichetta era stata il vero nume tutelare della casa, oltre che la musa discreta del marito letterato.
Nel frontespizio dell’Adelchi, che è del 1822, si leggeva «Alla diletta e venerata sua moglie…». “Diletta e venerata” e non semplicemente amata: parole che fanno pensare da un lato a quel misterioso libro che è Il Cantico dei Cantici («Sorgi diletta mia e vieni »), dall’altro evocano un sentimento che al poeta Manzoni, pur sempre romantico ancorché cattolico, fa apparire la sua donna già oltre il mondo degli umani, in una zona rarefatta dello spirito.
Donna di infinita dolcezza, è stata forse la persona che più di ogni altra ha ispirato all’autore de I Promessi Sposi la figura di Lucia, l’eroina del suo grande romanzo: come quei pittori che ritraevano nelle loro tele il volto della moglie, di cui non avevano mai smesso di essere innamorati. A questa donna minuta, mite e dai modi apparentemente sottomessi ma a suo modo volitiva, graziosa la sua parte, certo diversa dall’avvenente e vivace Giulia, sua madre, Alessandro doveva molto, forse doveva tutto. Possiamo solo immaginare la trepidante angoscia che dovette albergare nel cuore di Manzoni in quei giorni di aggravamento della sua già malferma salute.
L’adorata Enrichetta transitò in Cielo alle ore otto della sera di quel fatale Natale del 1833. Non ci è dato di conoscere i moti dell’anima, certo tempestosi, di Alessandro in quelle ore e nei giorni che seguirono. Chi può penetrare il mistero di un’anima? E di quell’anima? Al massimo possiamo conoscere noi stessi, come ammonisce il grande vescovo di Ippona, e solo Cristo, rivelando Dio all’uomo, svela l’uomo a sé stesso, come ben sapeva l’agostiniano Manzoni.
Manzoni, che pure cerca di trovare una risposta alla sofferenza, quando giunge al dilemma intellettuale, cui la ragione sembra condurlo, se negare la provvidenza o accusarla («Ti vorrei dir: che festi?/Ti vorrei dir: perché?», dicono due versi del primo abbozzo), ciò che a fronte della fede cristiana equivarrebbe a due bestemmie, scopre che anche nel silenzio di Dio vi è un disegno provvidenziale. E finisce per scegliere il silenzio. Non a caso le parole con cui si chiude, incerta, la poesia sono «cecidere manus» (“caddero le mani”). Ma perché Dio doveva rimanere impassibile di fronte al suo dolore?
Non era stato lui, qualche anno prima, scrivendo il suo romanzo, a mettere in bocca a Padre Cristoforo quelle parole, «Dio vi ha visitate», dirette a Agnese e Lucia minacciate dal sopruso di un potente? Convivevano in Manzoni due opposte tensioni: il coraggio e la paura, Padre Cristoforo e Don Abbondio, un tenero altruismo della sofferenza e la paura di veder soffrire: le lacrime invendicate di un bambino avrebbero procurato in lui lo stesso tormento che procuravano nell’anima di Dostoevskij.
Alla domanda “Perché, nonostante Dio, il dolore abita il mondo?” la risposta per lui è “Cristo”. Mai come in quel Natale questa risposta, da verità accarezzata solo con la mente, si faceva anima e carne. Nel sacrario più intimo della sua coscienza dovettero risuonare a lungo le prole di Giobbe di fronte alla sventura: «Il signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore». Egli, in quei giorni di sventura, tocca con mano la verità, a lungo meditata, che Dio si fa più presente quando chi lo prega si riconosce nudo, impotente, ed è già un miracolo un uomo o una donna che prega, che chiede a Dio di impolverarsi delle sue piccole o grandi miserie quotidiane.
Del dolore il grande romanziere aveva scritto in pagine memorabili (si pensi alla madre di Cecilia, fiore di poesia cresciuto nella desolazione della sventura collettiva della peste di Milano), ma non aveva ancora frequentato le sue aspre latitudini. Mai, prima di quel Natale, poesia e dolore dovettero apparirgli così profondamente intrecciati. Il presepe e la croce.
Da questo dramma personale del Manzoni emerge la debolezza dell’uomo e della storia nei confronti del dolore. Mentre scrivo di questo episodio, lontano 190 anni esatti ma vicino come se si svolgesse nell’altra stanza, mentre risuona ancora nella mente lo stanco ritualismo degli “auguri di buon Natale” (ma “auguri” di che? … del panettone, del torrone, del cenone da consumare il 24 a sera?), infuriano, in questa «aiuola che ci fa tanto feroci» gli inferni dell’Ucraina e del Medio Oriente, e l’uomo è annientato dall’uomo. Quanti bambini, piccoli Cristi, sono violati e uccisi in questi nostri giorni di violenza dei grandi.
Ci fu, in un Natale di tanti anni fa, un giovane padre, da sempre appassionato di Manzoni, che augurava ogni bene al suo bambino. E ci fu una ragazza di Nazareth, della casa di Davide, che partorì in una stalla perché non c’era posto in albergo per lei e per suo marito. Quella donna ci ricorda che, finché camminiamo sui sentieri della vita, la gioia, per quanto intensa possa apparirci, ha sempre le radici a forma di croce.
Manzoni ne fece esperienza in quel Natale del 1833, noi che ci diciamo cristiani non dovemmo dimenticarlo quando ci scambiamo gli auguri di Natale. Altrimenti è il Dies Natalis Solis Invicti, il solstizio d’inverno, il Natale pagano, quello che festeggiamo. La saggezza del popolo cristiano, col suo infallibile sensum fidei, ha sempre visto la croce sullo sfondo del presepe, e chiama “Pasquetta” quella festa dell’Epifania in cui si bacia il Bambinello.
Il grande scrittore capì, perché lo sentì nella sua carne e non solo nella sua anima (appena nove mesi dopo verrà a mancarle, in giovanissima età, anche la primogenita Giulietta) che alla croce di tutti i giorni, a cui ci chiama il Signore della storia, quella storia che vista dal lato dell’uomo è spesso storia di forza bruta, non ci è dato di sfuggire. Altrimenti “Dio” diventa un concetto vuoto, un vizio della mente, una sublime scaramanzia: un Dio a nostra immagine e somiglianza, anzi a nostra misura. E invece:
Sì che tu sei terribile
Sì che tu sei pietoso!
Indifferente ai preghi
Doni concedi e neghi.
Ti vorrei dir: che festi?
Ti vorrei dir: perché?
Non perdonasti ai tuoi
Non perdonasti a te. …
Giuseppe Lalli