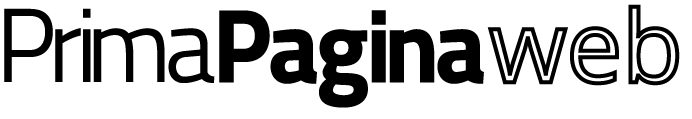Molto si è parlato e letto dell’articolo 18, e di lavoratori, sindacati e politici che hanno espresso la propria opinione,
ma sappiamo davvero di cosa si parla? Intanto va precisato che non si tratta dell’abrogazione dell’articolo 18, ma della sua modifica.
Tale modifica appare come il perno attorno al quale far ruotare la riforma del Lavoro, con tutti i dubbi del caso.
L’articolo 18 fa parte della Legge 14 maggio 1970, n°300, conosciuta come Statuto dei Lavoratori. Approvata a larga maggioranza, la norma in argomento è ritenuta il testo di riferimento più importante in materia di diritto dei lavoratori.
L’Articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori prevede che in caso di licenziamento “senza giusta causa o giustificato motivo”, il datore di lavoro che impiega nella sua azienda più di 15 dipendenti ha l’obbligo di “reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro”. Ma cosa si intende per “giusta causa” e “giustificato motivo”?
Con l’espressione “giusta causa” si indica un accadimento in cui c’è stata una gravissima inadempienza che non consente la prosecuzione del rapporto di lavoro.
Un esempio di questa inadempienza può essere l’aggressione del datore di lavoro o un incendio che distrugge il locale.
Tale evento può sfociare nel licenziamento, in cui il lavoratore viene costretto ad abbandonare immediatamente il posto di lavoro, trattasi del famigerato “licenziamento in tronco”.
Altra causa di licenziamento può essere il “giustificato motivo”, che si verifica quando il lavoratore crea un danno
concernente l’attività produttiva, per esempio danneggiando dei macchinari o non rispettando l’ “obbligo di fedeltà”, in pratica non rispetta il segreto su tecniche o fasi del processo produttivo, etc.
Al verificarsi di tali eventi il lavoratore può essere licenziato ma continuerà la sua attività lavorativa remunerata per un periodo normalmente individuato con il termine di “preavviso”.
Tuttavia, se il giudice, “accertata l’inefficacia o l’invalidità” del licenziamento, “dichiara la nullità a norma della legge
stessa” di tale atto, il datore di lavoro è obbligato a pagare al lavoratore “un’indennità commisurata alla retribuzione
globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi
assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell’effettiva reintegrazione; in ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione globale di fatto”. Ma non solo: fermo restando l’obbligo per il datore di lavoro di versare detto risarcimento, il lavoratore al posto della reintegrazione può richiedere “un’indennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto”. Se invece il “lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell’invito del datore di lavoro non abbia ripreso il servizio, né
abbia richiesto entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza il pagamento dell’indennità di cui
al presente comma, il rapporto di lavoro si intende risolto allo spirare dei termini predetti”. E’ bene sottolineare che l’Articolo 18 parla di reintegrazione e non di riassunzione.
Tra le due forme corre infatti una differenza sottile a livello linguistico, ma sostanziale a livello fattivo: nel primo caso, infatti, il lavoratore torna a occupare il proprio posto di lavoro conservando l’anzianità di servizio e i diritti acquisiti col contratto da lui firmato all’atto dell’assunzione, mentre nel secondo caso diventa a tutti gli effetti un dipendente neo-assunto.
Con la modifica dell’articolo 18, in sostituzione della reintegrazione forzata, viene inserito un indennizzo, che può
oscillare dalle 15 fino ad un massimo di 24 mensilità. E’ necessario sottolineare che la percentuale di lavoratori che hanno chiesto il reintegro dopo aver vinto la causa è esigua.
Si immagini cosa significhi tornare in un posto dove si è già stati licenziati una volta; ne residua che la prospettiva
dell’indennizzo è un’ alternativa particolarmente appetibile per i “licenziati”.
PrimaPagina, edizione settembre – di Daniela Palantrani