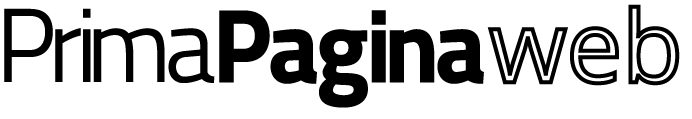Numerosi studi hanno ormai dimostrato che le esperienze sfavorevoli infantili (ACE: Adverse Childhood Experiences) hanno effetti negativi a lungo termine,
Numerosi studi hanno ormai dimostrato che le esperienze sfavorevoli infantili (ACE: Adverse Childhood Experiences) hanno effetti negativi a lungo termine,
lasciando tracce significative non solo sulla psiche, ma anche sulla salute fi sica dell’adulto. Se nell’indagare il vissuto intrapsichico della vittima si passa a sondare la sua percezione dei rapporti signifi cativi, ci si può rendere conto che ripercorrere le modalità delle rivelazioni dell’abuso, o viceversa la sua incapacità di raccontarle, ci conduce direttamente al cuore delle relazioni familiari, il cui funzionamento spinge il bambino a confi darsi o a tacere, quasi come se l’abuso fosse un rivelatore della qualità dei legami in cui il piccolo è immerso. Per illuminare una materia tanto ostica e misteriosa, che ci chiede di gettare uno sguardo nel futuro, si possono comunque elencare alcuni fattori che, influenzano l’esito dell’abuso: 1. La relazione con l’abusante; 2. L’età della vittima. Più il trauma è precoce, più distruttivo può rivelarsi. Ma anche: più la psiche è plastica, più la ferita può rimarginarsi; 3. Le modalità con cui l’abuso è stato agito; 4. La durata, anche un singolo gesto può avere esiti drammatici; 5. Le reazioni della vittima: più la vittima è riuscita a difendersi, a ottenere l’interruzione dell’abuso, a chiedere aiuto successivamente, a rivelare precocemente, meno intensi e pervasivi saranno i sensi di colpa; 6. I fattori di protezione intra ed extrafamiliari, il cui intreccio complessivo si somma alla dotazione di risorse individuali a determinare il fenomeno noto come resilienza. Quando trattiamo in psicoterapia uno di questi pazienti, tutti questi fattori si affollano nell’animo della persona, che ci rivolge (e soprattutto si rivolge!) senza sosta sempre le stesse domande: perché io? Cosa c’era in me di sbagliato che ha fatto sì che l’abusante abbia scelto proprio me? Perché non mi sono difeso? Perché non ho parlato prima? La ripetizione dell’abuso, questa terribile eventualità, regolarmente citata dalla letteratura scientifica, è ormai ampiamente divulgata, tanto da rappresentare una preoccupazione non minore nelle vittime ormai adulte che chiedono aiuto. Questi pazienti, sia che siano già divenuti genitori, sia che riflettano sulla possibilità di diventarlo, regolarmente domandano: “E’ vero che c’è rischio che anch’io abusi di mio figlio? Allora preferisco farla finita! Per non soccombere al trauma e per difendersi dal meccanismo di identifi cazione con l’aggressore, il bambino vittima, inerme e impotente, sposta nel futuro una sorta di rappresaglia e di vendetta. “Non sarò sempre così piccolo e debole, diventerò grande e forte, e allora gliela farò vedere io”. Il meccanismo implica però un prezzo molto costoso per la psiche, perché obbliga ad una scissione della mente. D’altra parte la coazione a ripetere l’abuso risponde all’esigenza di rivivere il trauma vissuto, questa volta però controllandolo – e non più subendolo – grazie allo scambio di ruolo. Per farlo, deve per così dire uccidere una parte di sé, sopprimendo l’empatia per il bambino che diventa la sua vittima. Non tutti i bambini abusati, fortunatamente, si trasformano in aggressori: ce ne sono alcuni, però, la cui triste sorte sembra essere la condanna a rimanere vittime. Questa seconda categoria di pazienti non li incontriamo quindi come genitori maltrattanti inviati dal Tribunale a servizi specializzati nella tutela, ma come soggetti che chiedono aiuto negli studi privati di psicoterapia o nei servizi consultoriali e psichiatrici, con domande di presa in carico per patologie depressive o ansiose, in personalità caratterizzate da scarsa assertività, dipendenza, insicurezza nella relazione con gli altri. Se nel primo gruppo l’aggressività era ipertrofica e incontrollata, in questo è repressa e censurata, in una sorta di autocastrazione. In sintesi, possiamo dunque dire che il legame di attaccamento sia un fattore discriminante per predire gli effetti a lungo termine dell’abuso: tanto più intenso è il terrore associato al trauma, tanto più necessaria è la presenza di fi gure sicure e responsive, che salvino la piccola vittima dal lo sprofondare nel vissuto di abbandono provocato dalla propria inerme solitudine, che porrebbe le premesse per l’identificazione con l’aggressore. Per questa ragione, alla nostra domanda iniziale possiamo con una certa ragionevolezza rispondere che la presenza di fi gure in grado di garantire un attaccamento sicuro diminuisce le probabilità di esiti infausti costituendo un fondamentale fattore di resilienza. E’ perciò fondato orientare il nostro lavoro di prevenzione non solo al sostegno diretto alla piccola vittima, ma anche a quello indiretto, che passi attraverso il supporto al genitore potenzialmente protettivo.
PrimaPagina, edizione Ottobre 2014 – Dott.ssa Chiara Fossemò