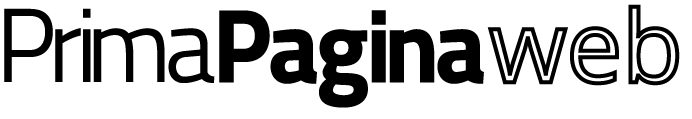L’OSPITE – di Luigi Fiammata
L’OSPITE – di Luigi Fiammata
Del sole restava un riflesso rosa ferro sulle nuvole, lontane, fin dove lo sguardo si fermava sulla montagna alta.La sera era diventata fredda e le ombre allungavano il buio.
Hebib sistemava dei rametti secchi, sopra la paglia gialla, poggiata a terra, dentro un cerchio di pietre bianche, annerite dal fumo. Stava per accendere il fuoco della notte. Accanto a sé, aveva delle piccole cataste di rami. Separate tra loro; di spessore e pesantezza crescenti.
Prese un fiammifero dalla sacca di tela sformata che teneva a tracollo, lo accese, e lo tenne nel chiuso delle mani, per ripararlo dall’alito che scendeva lungo tutto il pianoro, andando ad infrangersi verso la collina sassosa, sulla destra. Il fuoco rosso, iniziò a bruciare gli sterpi, e poi, con leggeri schiocchi anche i piccoli pezzetti di legno, lentamente, piegando la fiamma al vento serale, che dalle cime cadeva verso valle, come un respiro che riposava.
Hebib avvicinava le mani al fuoco, sentendone il calore leggero. E, con attenzione, iniziò a posare sulle prime piccole braci, dei rami più consistenti, facendo attenzione a che non soffocassero, le fiamme quasi invisibili, dello stesso colore del tramonto, che s’alzavano veloci dal cerchio di pietre.
Il fuoco, ora, era più alto, e attirava i grossi cani bianchi, dall’espressione severa, massicci, che, fino a quel momento, erano rimasti fermi, stesi sulla terra, pensosi, a guardare da lontano le pecore ammassate vicino ad una casa di pietre grigie, di cui si vedeva solo una parete alta, tutta compatta e chiusa, fino ad una piccola finestra posta al centro, in alto, quasi al congiungersi delle due linee del tetto. E dietro la finestra si vedeva il cielo scurirsi; dietro la parete, infatti, altre mura erano crollate; private di ogni sostegno, dal tempo che le aveva lasciate sole, senza più abitanti, quelle case. Si leggeva su un muro di ingresso, scritto con una vernice nera, l’Anno del Signore, milleottocentosettantuno.
Hebib, chiuse gli occhi, e, per la prima volta, dall’alba di quel giorno, sentì i singoli muscoli del proprio corpo. Ne avvertiva la presenza dal dolore. Quello della fatica che si è fermata. Che ha smesso di camminare e correre dietro gli agnelli. Di guardare se i piedi avessero disturbato serpenti. Quello delle salite nel sole, e nel silenzio assoluto e scuro del Fosso senza fondo.
Uno dei cani, iniziò ad abbaiare. Ed Hebib riaprì subito gli occhi.
Sapeva che in alcune di quelle case lì intorno, vuote e nude da decenni, i cavalli andavano a rifugiarsi quando era maltempo, e quel pavimento, trasformato in un ammasso di letame, talvolta era stato il letto di qualche orso. Se ne vedevano i peli in giro, lasciati sugli angoli di pietra a marchiare il territorio, e in quel letame, la fossa dell’orma del corpo steso, ogni tanto.
Hebib alzò allora lo sguardo.
Dal pendio della collina, in controluce sul tramonto, scendeva, incerta, l’ombra di un uomo. Di cui non poteva distinguere i lineamenti. Mise una mano sugli occhi, per difendersi dal riverbero, e capì che non poteva essere il suo padrone.
L’uomo camminava piano, come se ogni passo poggiasse su una terra in movimento; un mare di onde mai ferme. Hebib chiamò a sé tutti i cani. E ne fermò l’evidente intenzione a slanciarsi contro l’uomo che arrivava.
– Chi sei, tu ? – Chiese Hebib.
– Il mio nome è Cosimo. – Rispose l’uomo.
Cosimo indossava un vecchio giubbetto militare di panno, che conservava l’impronta delle mostrine, e dei gradi, ora strappati. Lacero, senza un paio di bottoni. E pantaloni consumati, sulle ginocchia, e all’orlo, logorato dallo sfregare in terra, camminando. E vecchi anfibi neri ai piedi, di cuoio liso dal tempo e dai passi. Senza più colore, in punta.
Doveva avere poco più di una quarantina d’anni, Cosimo; la barba incolta, sotto il mento, stava riempiendosi di peluria bianca, come le tempie, rasate. Le labbra erano piene, carnose, e ben disegnate, sotto un naso dritto, quasi affilato, magro.
Le sue mani, erano secche, nervose e forti. Segnate da vene pronunciate e tendini tesi; chiuse a pugno, come a contenere una continua tensione che non trovava requie.
Hebib capì, dalla polvere che Cosimo aveva indosso, dalle macchie verdi sui pantaloni e sul giubbetto, che l’uomo che aveva davanti doveva aver camminato molto, e che doveva anche esser caduto, camminando. O che, forse, s’era riposato, stendendosi sulla terra nuda.
E capì anche ch’era inquieto.
Cosimo si muoveva guardandosi intorno, e dietro. A scatti, come se s’aspettasse, da un momento all’altro, un pericolo, incombente, inevitabile. Necessario.
Hebib invitò Cosimo a sedersi, accanto a lui, vicino al fuoco.
– Dimmi, e dimmelo veramente. Ma, come mai, arrivi qui, di sera, da solo? Da dove provieni? Chi è la tua famiglia? –
Così, gli chiese Hebib, guardandolo negli occhi, come se questo potesse consentirgli di ricevere una risposta sincera.
– Mi chiamo Cosimo, ti ho detto. Ora, mi vedi in mezzo ai monti, ma, un tempo, io ero un marinaio; ero il nocchiero della nave su cui ero imbarcato e solcavo i mari, scuri come un vino buio e bianchi talvolta come un anziano arrabbiato, di ogni mondo. E non avevo paura della notte, e le stelle mi erano amiche e consigliere, nella rotta, più degli strumenti di bordo.
Ed ogni porto, dove io mi avvicinassi alle riparate sponde, e trovassi rifugio dai venti del nord, era la mia casa. E ad ogni porto io cercavo la mia dolce madre, mai conosciuta, e per lei acquistavo doni. E un giorno, quando l’avessi trovata, glieli avrei consegnati, quanti ne avevo ammassati, se il dio degli oceani, che scuote la terra con i terremoti del suo tridente, non mi avesse un giorno rovesciato la sorte.
La nave sulla quale viaggiavo, al largo dell’isola di Creta, venne colpita da una orribile tempesta. Le onde erano più alte delle murate della nave, e la prua affondava sempre più dentro l’acqua, tentando di cercare una direzione che la salvasse. Ma la furia del mare si abbatté su di noi, come un grifone su un agnello. E, prima, staccò i container che trasportavamo, dai loro alloggiamenti sul ponte della nave, e poi li fece correre portati dall’acqua, fino quasi a staccare, per i colpi terribili, il castello di poppa, provocando schianti più forti del tuono. Fu scosso e liberato anche il carico contenuto nella stiva, che arrivò a squarciare la chiglia, e a trascinare a fondo la nave, in un enorme gorgo che inghiottì tutti gli altri marinai, uomini come me, e miei amici, che mai più avrebbero rivisto le loro terre, e le loro famiglie, fino a sciogliergli le ginocchia e il cuore, uccidendoli .
Forse fu una dea pietosa, che mi fece galleggiare, aggrappato ad un relitto di legno, non so quanti giorni, e notti, senza mangiare o poter bere, fino ad essere lasciato, inerme e senza conoscenza su una spiaggia sconosciuta. Di sabbia bianca, sulla quale si riversavano le acque dolci e fresche di un piccolo fiume.
Io ero praticamente nudo, e coperto di salsedine e alghe, quando un gruppo di ragazzi mi ritrovò. Loro giocavano a palla, e gli volò via, la palla, col vento, fino a me, nascosto dietro un cespuglio. Vergognoso e ferito, e senza memoria, salvo che del mio nome.
Mi portarono nella casa del più grande tra loro; mi presenteranno alla sua famiglia, e, credo, raccontarono al capo famiglia, come mi avessero trovato solo e sudicio, e mi permisero di fare una doccia, con un sapone profumato, e mi regalarono nuovi vestiti, anche senza conoscermi. E mi fecero mangiare. E bere. Senza chiedermi nulla, o ragione, del perché fossi lì.
Dovevo essere in Africa, pensai, perché loro erano tutti di pelle nera, e parlavano una lingua che io non so ricordare, né che allora comprendessi. Mi donarono anche delle cose da mangiare, e degli animali scolpiti in legno, perché non mi dimenticassi di loro, una volta lasciatili, e mi accompagnarono fino alla città più vicina. Che scoprii, essere Bengasi. In Libia. E, da lì potei tornare in Italia, approdando in Sicilia. –
Hebib guardò Cosimo, e gli chiese se avesse fame. Cosimo rispose che non mangiava dal mattino. Allora Hebib s’alzò, e si diresse verso il gruppo di piccole case. Ne superò una, con l’ingresso sfondato, che faceva intravedere un vestibolo, ampio, con la volta a crociera; le pareti costruite di piccoli mattoni d’argilla cotta, e così l’arco del soffitto, incrociato, mirabilmente tenuto in equilibrio da una meccanica di spinte e contro spinte. Sul pavimento, si vedevano tegole di coccio, scivolate dal tetto, qualcuna spezzata; quelle ancora non portate via da saccheggiatori senza scrupoli. E arrivò fino al pozzo artesiano. Lì, iniziò a tirar su la corda, cui era appeso un grosso secchio, utilizzato per conservare cibo, in profondità, al fresco, vicino l’acqua ancora affiorante.
Prese un paio di salami, e un pezzo di formaggio, e del pane. E una bottiglia di vino piena a metà.
E divise il cibo con Cosimo. E entrambe ne presero finché furono sazi. Quasi senza parlare, rispettando il silenzio dei pensieri, e il passo forte dei cani, che giravano intorno al fuoco, mentre la notte diventava chiara di stelle lattee. Hebib, lisciandosi i baffi, mentre ancora mangiava del formaggio, dal sapore di pascolo primaverile, iniziò a parlare a Cosimo.
– Io, Macedone. Mio nome Hebib. Io, perso mia famiglia, qui in Italia, da ragazzo. Incidente di macchina. Mio padre era pastore, qui. E io ho preso suo posto. Padrone me fa lavorare, e io lo ringrazio, e io vivo qui, in montagne, tra Roio, e Lucoli. Ogni tanto, padrone mi paga ritorno da miei parenti, in Macedonia.
Io sto bene qui. Ma se Macedonia inizia guerra per unire tutto popolo macedone, di Grecia, di Bulgaria, di Albania, io parto, e vado in guerra.
– Ma in guerra si muore… – disse Cosimo.
– Anche a vivere, si muore. E’ importante, come si vive, ma anche come si muore. E’ importante, se muori e pensi che è giusto. –
– Forse, forse hai ragione, ma noi uomini dovremmo essere stanchi, di guerra; stanchi di dividerci tra popoli, mentre siamo solo tutti umani.-
– Belle parole. Io contento, aver ospitato te. Avere diviso con te mio pane. Mio Dio è contento, se onoro ospite. A me, mia famiglia, insegnato così. Ma io penso che morte, è parte del vivere. E non mi importa morire in guerra, se questo è per mio popolo. –
– Sono stanco, Hebib, di guerre. Io le ho viste, le guerre. E il sangue, dei morti. Siamo tutti vinti, in guerra Hebib. Bello, sarebbe vivere, senza la paura del morire.-
– No paura, di morire. Se io, paura di te, io mandato addosso cani, no? Tu no mangiare, e niente caldo vicino al fuoco. Guarda quanto è nera montagna. E’ quella che fa paura, no? Notte senza luce, come morte e occhi chiusi; però se accendo legna, ecco luce, ecco caldo. Ecco brace, per cucinare. Così è luce, se vivo e muoio bene. –
Hebib offrì a Cosimo una coperta, che aveva recuperato in uno zaino, poggiato in una scaffalatura di mattoni intonacati di ocra, incassata nel muro interno di una casa vicina, di sassi grigi, senza più tetto, ma solo con grandi travi di legno rimaste confitte in cavalletti di pietra ricavati al termine delle pareti, sospese sul nulla, verso il cielo, a lasciare ombre, di stelle, nel buio della stanza vuota.
Avvolsero la coperta sulle spalle, e si versarono un altro bicchiere di vino, alimentando il fuoco. L’odore delle pecore, sembrava salire dalla terra. Umido, e peloso. Odore di zampe mai ferme e terra calpestata. E di sterco.
Anche un lupo lontano, l’avvertiva. Un ululato distante, colmò per un attimo il silenzio della notte. I cani alzarono le orecchie. E uno di loro, dimenando la grande coda bianca, s’alzò, e si diresse, camminando lentamente, verso il buio, là dove era nato il suono.
Il sapore del vino, era leggermente aspro, in bocca, e fresco. Come un’uva quasi matura, che conservi ancora un po’ il sapore verde della vite. Ne bevvero piano, dai bicchieri. E ne furono soddisfatti. Mentre si guardavano, e la notte sembrava rotolare lungo i fianchi delle colline vicine, addensando l’oscurità intorno a loro. Quasi solida, lenta. Un lago fermo.
Solo con qualche bagliore più forte, della legna che veniva aggiunta, si poteva scorgere il profilo traballante delle casette, ammucchiate dietro le loro spalle. Persino il silenzio, appariva timoroso, come Cosimo. Che continuava ad essere in allarme. Incerto. Sgomento.
La terra, s’era raffreddata, sotto i corpi di Cosimo, ed Hebib, distesi al fianco del fuoco, con la testa poggiata sulle braccia, dentro un sonno breve, e attento. Una pausa dei respiri. E dei pensieri, e degli sguardi.
Si risvegliò Cosimo. Sedette a terra, le gambe incrociate. Alimentò il fuoco con un piccolo ciocco spesso e nodoso. Dalla parte della montagna più alta, sembrava iniziasse a sorgere dalla roccia un celeste inatteso.
E iniziò a parlare, Cosimo, a bassa voce, mentre Hebib era ancora steso a terra.
– E’ come accorgersi, per la prima volta, e davvero, che tutto può finire. E’ qualcosa cui non credi. Fino in fondo non ci credi. Ti guardi le mani, e pensi che non possono restar ferme. Ti senti le gambe, e pensi che ti sostengono, ancora. Anche una gamba sola. T’ascolti il cuore, sulla vena del collo, e lo senti battere. Ti pare veloce, quando immagini sia veloce, e lento, tranquillo, quando provi a respirare, e sentire davvero, il tuo stomaco, e l’aria che ci entra, inspirando profondo. Non può, finire, tutta questa perfezione che non ha ragione alcuna, visibile, di finire.
E però sei su una vertigine, sul crinale di un gorgo che ti succhia dentro. Basta un istante, basta un pensiero piccolo, che ti sfugga al controllo, basta che pensi, che so, a come sarà davvero, il momento del dolore assoluto, del distacco, e della fine, che, ecco, ecco che le orecchie iniziano a ronzare e il respiro si spezza e diventa corto e stretto, e breve e mozzo e compresso e schiacciato e sibila e non riesce, e si ferma. E ti pare che un’ombra t’abbia tolto ogni coscienza, e ogni memoria. Un’ombra che t’ha reso il tempo un attimo, ed è il solo ed unico attimo che puoi vivere, ancora. Anche se non ci credi. Che sia così. E non riesci a muoverti, e sei immobile, e sei bloccato, e hai paura che ogni tuo gesto possa rompere l’equilibrio che ti permette ancora, comunque, di pensare. E cerchi il cielo… e cerchi il respiro… un altro respiro ancora… –
Cosimo s’alzo di scatto.
E il suo movimento, si trasmise ad Hebib, che, subito, sollevò il busto verso Cosimo, e lo guardò interrogativo.
– Hebib, dimmelo, per favore, come posso fare per arrivare alla città più vicina, e come si chiama questo luogo, dove siamo. –
– Puoi arrivare a Santa Rufina di Roio, basta che vai nella direzione del sole che nasce. E cammini in discesa. C’è un sentiero di pietre. Strada non difficile. Qui, chiamano Case Michetti. Una volta, qui, l’estate, vivevano pastori come me, ora, solo io. –
– Allora, vado Hebib, e grazie d’avermi accolto, e dato da mangiare, anche se non mi conoscevi, e ora però un po’ mi conosci… –
– Addio, Cosimo… tu avresti fatto uguale, con me. Buona strada. –
Cosimo camminava, dando le spalle ad Hebib, che cercava con gli occhi i cani, e le pecore, per cominciare il giorno nuovo, mentre l’aurora colorava d’arancio le dita di un pezzo di cielo, alle spalle dei monti. Dalla parte del mare, verso la Macedonia.
Fu a metà mattinata, mentre Hebib sedeva su una grossa pietra, al pascolo, che vide dirigersi verso di lui diverse persone. Tenevano dei cani al guinzaglio. Qualcuno era in divisa da carabiniere.
Chiesero ad Hebib se avesse visto qualcuno.
Cercavano un uomo.
E gli spiegarono, chi cercavano.
Un ex militare, impegnato a suo tempo in Iraq, che aveva perduto la ragione, dopo aver assistito allo scempio provocato su una scolaresca di ragazzine da una autobomba, anni prima. Nessuno ricordava più quanti. Aveva circa quaranta anni, una barba leggera, i capelli corti. S’era smarrito. O forse era scappato.
Hebib non disse nulla. Disse solo che non riusciva a capire.
Liberamente ispirato al dialogo tra il porcaro Eumeo ed Ulisse.