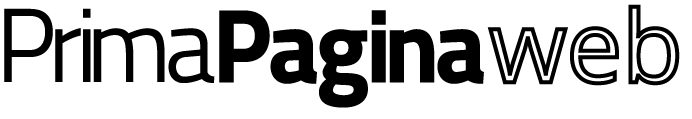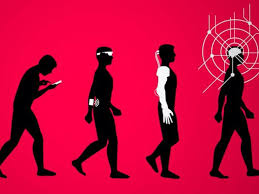
di Carlo Di Stanislao
“Nelle situazioni avverse mostrati coraggioso
e forte: sempre tu, saggiamente, ammainerai
le vele gonfie per un vento troppo favorevole”
Orazio
Orazio è il padre del “carpe diem”. Un invito immortale a non farsi troppe domande nella vita, ma cercare la bellezza in ogni sua cosa. Vissuto durante l’età dell’oro della letteratura latina, era un maestro nell’arte di trasmettere concetti filosofici attraverso la poesia. Il messaggio centrale di questi versi è l’importanza dell’equilibrio, un concetto caro agli stoici, ma che Orazio adatta con un tocco di umanità e realismo. Il poeta ci esorta a non lasciarci sopraffare dalle avversità, ma a mostrare coraggio e forza d’animo. Questo approccio bilanciato alla vita è una riflessione sull’instabilità delle fortune umane, un tema che ricorre spesso nella letteratura classica. La “fortuna”, intesa come il destino mutevole degli eventi, è imprevedibile e inaffidabile. Orazio ci consiglia quindi di non permettere che il vento delle circostanze, sia esso favorevole o contrario, determini completamente il nostro stato d’animo o il nostro comportamento. Nel linguaggio corrente si utilizza la parola “stoico” per indicare un comportamento ammirevole per virtù, saggezza e coraggio. Per gli stoici, d’altra parte, lo scopo del vivere è il raggiungimento della felicità. L’etica deve determinare in che cosa esattamente consista la felicità e quali siano i mezzi appropriati per raggiungerla.
Per gli stoici, la soluzione di questo problema costituisce non lo scopo di un settore della filosofia ma lo scopo unico di tutte quante le parti della filosofia: la logica, la fisica e l’etica. Alla filosofia si chiede, insomma, l’arte di vivere. La storia di Epitteto è emblematica: da schiavo studia, diventa un uomo libero e fonda una propria scuola (a Nicopoli, nella Grecia nord-occidentale). Lo stoicismo, mettendo in crisi gli antichi miti della nobiltà del sangue o della superiorità della razza, proclama che la natura peculiare dell’uomo è la ragione, il logos, e l’uomo deve vivere attuando proprio la ragione. Quindi, l’uomo – indipendentemente dalla sua condizione personale, sia esso potente o umile o schiavo – viene proclamato libero e capace di giungere alla virtù: vero libero è il saggio, vero schiavo è lo stolto. Non c’è quindi da meravigliarsi se nello stoicismo ritroviamo fianco a fianco un imperatore, Marco Aurelio, e un ex schiavo affrancato.
Ma oggi possiamo chiedere ai filosofi attuali regole per restare uomini e quindi felici nelle avversità? Possiamo trovare in un universo in cui il meglio è rappresentato da Galimberti e Cacciari, indicazioni e parole per uscire dalla falsa felicità fatta di calcio, tennis, spiagge affollate, vacanze intruppate e diffuse paure ecologiche, infettivologiche, di guerre diffuse e via discorrendo? Ben vivere, cioè soffrire senza avvilirsi è un problema antico quanto l’uomo. Attualmente, ahimé, la ricetta sembra essere quella di aderire a una di quelle dottrine New Age che uniscono un po’ di tutto: yoga e yogurt, fitness e meditazione, saggezza e massaggi. Lo stoicismo invece richiede impegno, poiché stabilisce che l’unica cosa degna di essere perseguita e coltivata sia la virtù morale; considera invece ‘indifferenti preferibili’ la salute, la conoscenza e la ricchezza (anche se gli stoici non predicavano certo uno stile di vita ascetico, anzi: molti tra loro avrebbero dimostrato di sapersi godere le cose belle della vita).
A fronte di ciò, qualsiasi lista di intellettuali contemporanei è destinata ad apparire insoddisfacente. Se ne sono accorti anche al New York Times, quando l’editoralista Ross Douthat ha tentato di stilare un elenco dei pensatori più influenti – che non significa migliori – del nuovo millennio. Una delusione. Si va da Ta-Nehisi Coates a Slavoj Žižek, insieme a Peter Thiel, Ibram X. Kendi e, udite udite, Robin DiAngelo (l’inventrice del concetto di “fragilità bianca”). Non manca il discusso Jordan Peterson e il best seller Yuval Noah Harari. Quale di questi nomi potrebbe diventare il prossimo Dostoevskij o il futuro Karl Marx?Il timore è che la risposta sia: nessuno. È un malessere che pervade la cultura occidentale e l’anglosfera in generale, anche se i nomi apparsi altrove non incoraggiano granché. Nel mondo della letteratura, che ha spesso funzionato come un serbatoio di riserve della repubblica degli intellettuali, la situazione appare simile: tutto langue.
La forma romanzo è meno in crisi di quanto si pensasse, quella della poesia invece è messa peggio. In ogni caso, mancano i Philip Roth e i Saul Bellow. Mentre altrove qualcosina si muove ancora: Michel Houellebecq in Francia e Karl Ove Knausgaard in Norvegia, ma nonostante l’indubbia qualità le aspettative non sono alte. Le ragioni di questa fase di stanchezza sono diverse. Douthat le trova nel radicalismo degli anni ’60, che ormai (dopo 60 anni) ha perso la spinta di una volta. Altri nella malinconia innescata dal post-1989 e dalla cosiddetta fine della storia. Oggi mancano idee, libertà ed avanguardie che trascinano verso l’alto. Nel Portogallo della Prima Guerra Mondiale è emerso Fernando Pessoa, il realismo viscerale del Messico degli anni ’70 è tornato in Roberto Bolaño (il suo “I detective selvaggi” è una lettera d’amore a quei movimenti underground che rubavano libri dai mercatini e odiavano i letterati più celebri, tanto da voler rapire il poeta Octavio Paz). “Forse mi inganneranno la vecchiaia e la paura, ma sospetto che la specie umana – l’unica – stia per estinguersi e che la Biblioteca sia destinata a permanere: illuminata, solitaria, infinita, perfettamente immobile, armata di volumi preziosi, inutile, incorruttibile, segreta”. La frase di Jorge Luis Borges è tratta da una delle sue opere più emblematiche, La biblioteca di Babele e sembra ora quanto mai veritiera. Nell’immaginario borgesiano, la Biblioteca rappresenta un universo metafisico, una costruzione in cui sono contenuti tutti i libri possibili, scritti in ogni combinazione immaginabile di lettere e simboli.
L’idea che la Biblioteca rimanga immutata e incorruttibile, mentre l’umanità si estingue, solleva importanti interrogativi esistenziali. Questa biblioteca infinita diventa una metafora dell’universo stesso, un luogo dove ogni evento possibile è scritto in una sorta di libro cosmico, ma che, allo stesso tempo, risulta essere caotico e privo di senso. Borges gioca con l’idea che, sebbene la conoscenza sia potenzialmente infinita, è anche impossibile da comprendere o decifrare completamente. L’idea che la Biblioteca rimanga immutata e incorruttibile, mentre l’umanità si estingue, solleva importanti interrogativi esistenziali. Borges ci porta a riflettere sulla possibilità che la conoscenza e la cultura, accumulate nel corso dei secoli, possano sopravvivere alla nostra stessa specie. Tuttavia, la frase “infinita, perfettamente immobile, armata di volumi preziosi, inutile” ci avverte dell’inutilità di questa sopravvivenza. Una Biblioteca senza lettori, senza esseri umani che ne traggano significato, diventa un luogo inutile, una reliquia del passato, perfetta nella sua conservazione, ma priva di vita. In un mondo sempre più minacciato da crisi ambientali, guerre e catastrofi naturali, l’idea che l’umanità possa estinguersi non sembra più un’ipotesi remota. Borges anticipa con grande lucidità il senso di vulnerabilità che accompagna la nostra esistenza. La sua visione è inquietante: se l’umanità si estingue, cosa rimarrà della nostra cultura, della nostra conoscenza, delle nostre scoperte? La Biblioteca, simbolo dell’intera eredità culturale umana, potrebbe rimanere intatta, ma a quale scopo? La frase “armata di volumi preziosi, inutile” è particolarmente significativa. Questa umanità è degna di questa immensa biblioteca?
Aristotele ci invita a riflettere su cosa significhi veramente essere degni e come la nostra percezione interna di merito sia fondamentale per il vero valore di qualsiasi riconoscimento esterno. “La dignità non consiste nel possedere onori, ma nella coscienza di meritarli” scrive l’ateniese e ci avverte che il possesso di onori non garantisce automaticamente la dignità. La dignità, infatti, è un valore intrinseco, radicato nella propria coscienza e nel senso di merito personale. In altre parole, non è il riconoscimento esterno che determina la nostra dignità, ma piuttosto la nostra consapevolezza di essere veramente meritevoli di tale riconoscimento. Un aspetto interessante della riflessione di Aristotele riguarda il pericolo della vanità e dell’autoinganno. In una società in cui l’apparenza spesso conta più della sostanza, è facile cadere nella trappola di cercare onori per ragioni superficiali. Ed invece di questo oggi noi esclusivamente ci nutriamo o aspiriamo a farlo.
“Secondo me, non c’è nulla di più sciocco della convinzione che quello che è familiare sia necessariamente rassicurante, e si tratta addirittura di una convinzione tipica della psicologia di massa.” La frase di H. P. Lovecraft, tratta da “Altri racconti”, tocca un tema fondamentale non solo nella sua opera, ma anche nella filosofia e nella psicologia umana: il rapporto tra familiarità e rassicurazione. Lovecraft, noto per la sua capacità di esplorare gli abissi dell’ignoto e del terrore cosmico, qui sfida un’idea profondamente radicata nella nostra mente: quella che associa ciò che è familiare con ciò che è sicuro e confortante. Ed ecco allora che il potere vero ci mostra diversivi semplici e rassicuranti, portati da personaggi addirittura peggiori di noi. Questa tendenza psicologica può portarci a ignorare o sottovalutare pericoli reali che si nascondono proprio in ciò che riteniamo familiare. Ad esempio, in ambito sociale o politico, potremmo continuare ad accettare norme, istituzioni o abitudini dannose solo perché fanno parte della nostra quotidianità, senza mettere in discussione la loro effettiva bontà o sicurezza. Questo meccanismo psicologico si estende anche alla nostra percezione dell’ignoto. Lovecraft è famoso per aver introdotto nei suoi racconti l’idea del “cosmic horror“, un terrore derivante dall’incontro con l’ignoto, con entità o fenomeni così alieni e incomprensibili da sfidare la nostra sanità mentale. Eppure, egli sembra suggerire che il vero terrore non risieda solo nell’ignoto, ma anche nel familiare: ciò che è vicino e noto può nascondere orrori altrettanto grandi, proprio perché non lo percepiamo come una minaccia. Lovecraft, nel contesto del suo tempo, osservava una società in cui il conformismo e la paura dell’ignoto si traducevano in un rifiuto di tutto ciò che era diverso, nuovo o sconosciuto.
Oggi quasi due secoli dopo è ancora peggio. Il ruolo prevale completamente sulla soggettività, fino al suo completo livellamento e cancellazione. Al guadagno di un’immagine socialmente approvata segue un’eclissi totale dell’essere più particolare della persona, con i relativi effetti sul piano psichico. E al di fuori dello sballo di un momento (una festa, un vincitore olimpico, ecc.) diventiamo depressi e vittime illusorie delle avversità (povertà, malattie, guerre e via dicendo). Il tratto che accomuna questi tipi di depressione è senz’altro un profondo senso di vuoto. Esso può prendere la forma o dell’apatia, dell’indifferenza, dello spegnimento di ogni vitalità, oppure al contrario dell’euforia e dell’iperattivismo sganciati però da ogni dimensione di vero piacere e di vera gioia. L’eccesso di adeguamento mimetico alle richieste della realtà e ai modelli imposti svuota l’essere umano, rendendolo simile ad una macchina performante ma priva del sentimento della vita. La sofferenza del provare ad essere se stessi, il conflitto, il fallimento, l’erranza vengono neutralizzati attraverso l’identificazione massiccia ad un sembiante sociale. Ma, insieme ai patimenti, in questi soggetti scompaiono pure le gioie, sparisce la vita stessa.
Un noto psicoanalista inglese, Christopher Bollas, definisce tali personalità “normotiche”. In effetti sono persone “anormalmente normali”, troppo normali, troppo conformiste. Spesso accade che abbiano successo all’interno di ambienti professionali che non incentivano creatività o indipendenza di pensiero, ma che privilegiano al loro interno la rigida osservazione di regole e protocolli. Il loro disagio è tendenzialmente invisibile, sembrano appunto normali”. Dentro sono morti ma nessuno se ne accorge, nemmeno loro stessi. Finiscono con il chiedere aiuto quando si trovano nella condizione di sentire finalmente qualcosa, frequentemente a partire proprio da un vacillamento del loro ruolo. Tipicamente un insuccesso lavorativo li getta nella disperazione più nera. Allora le emozioni, prima assenti, diventano travolgenti, ingovernabili. Capita anche che il loro malessere interiore diventi manifesto quando sono chiamati ad agire creativamente, quando per esempio devono prendere delle decisioni o più in generale in tutte quelle situazioni della vita in cui non basta seguire un modello ma bisogna attingere alla parte più profonda di se stessi, alla propria soggettività. L’amore spesso è un territorio che mette in difficoltà, perché fa appello a gusti e sentimenti personali. Un incontro davvero significativo può avere il potere di svegliare dal torpore, con tutto il correlato destabilizzante che tale risveglio finisce per provocare. E in assenza di questo incontro ci si affida al gruppo, al gregge. Il problema inizia proprio quando giustifichiamo le nostre azioni dicendoci: “lo hanno fatto anche gli altri”, trasformando la nostra identità individuale in identità di gruppo. Non ci percepiamo più come persone uniche e dotate di coscienza propria, ma come parte integrante di gruppi diversi in cui ci facciamo trasportare da quello che fanno gli altri.
Lo psicologo Solomon Asch si occupò di queste tematiche con un celebre esperimento del 1951, tra i più popolari nell’ambito della psicologia sociale in relazione alla conformità di gruppo. La semplicità del metodo e la generalizzabilità delle conclusioni sono alle base degli studi che indagano le influenze dei gruppi e delle maggioranze sulle scelte e sulle percezioni del mondo di un individuo. In questo studio Asch cerca di dimostrare come gli individui si comportano, e più specificatamente se sono in grado di andare controcorrente quando sanno che la maggioranza è in errore. La richiesta ai partecipanti era di fornire la risposta più corretta a un problema. All’interno del gruppo, vi erano alcuni partecipanti in accordo nel dare una risposta palesemente sbagliata. Tra i partecipanti ignari, un’alta percentuale diede la risposta sbagliata pur confessando che da soli avrebbero risposto diversamente. Questo dimostra quanto sia importante come si comportano gli altri e che cosa pensano, tanto da consentirci di adattare il nostro comportamento pur di essere accettati dal gruppo. Pur essendo consapevoli di fornire una risposta sbagliata, molti partecipanti hanno comunque preferito sbagliare pur di essere “accettati” e conformi al gruppo, e questo conferma come ci comportiamo conformandoci a quello che gli altri si aspettano da noi. Quindi vivere l’attimo e cercare in noi e a nostro modo la felicità è l’unica risposta alle diverse avversità, vere o presunte. E vero o presunto è il senso di allontanamento dei valori capitalisti e neoliberali del mondo occidentale americanizzato che si legge nel decreto firmato da Putin il 19 agosto scorso? E soprattutto: cosa c’è davvero dietro?
La condanna a un a un anno e tre mesi inflitta a Piercamillo Davigo per rivelazione del segreto d’ufficio ha, comprensibilmente, riempito le cronache dei giornali e dato spazio ai giudizi anche sarcastici dei commentatori per le caratteristiche del personaggio. La sorte ci ha messo la sua ironia. Davigo era stato rinviato a giudizio, lo scorso anno, nel giorno del trentesimo anniversario dell’arresto di Mario Chiesa e quindi dell’inizio dell’epopea di Mani pulite. E per giunta è stato condannato mentre il Senato commemorava la scomparsa e celebrava la figura di Silvio Berlusconi, la sua antitesi giudiziaria per tre decenni. La caduta nella polvere del moralizzatore fa rileggere con altro sapore tutta quella serie di aforismi e aneddoti giustizialisti che Davigo ha propalato per anni sui giornali e in televisione: dai colpevoli che la fanno franca agli innocenti non ancora scoperti, per arrivare alle ricadute sociali sugli imputati già a partire dal rinvio a giudizio con la trita e ritrita davighiana parabola del pedofilo: “Se il mio vicino di casa è rinviato a giudizio per pedofilia, io mia figlia di sei anni non gliel’affido quando vado a fare la spesa. Poi, se verrà scagionato, si vedrà”.
Già, si vedrà sempre dopo.
Mentre scrivo apprendo della morte a 79 anni di Ottaviano Del Turco, ex presidente della regione Abruzzo, vice segretario della Cgil, ultimo segretario del Partito socialista (Psi), nonché ex ministro delle Finanze dal 2000 al 2001, ma soprattutto finito al centro di un caso politico-istituzionale perché, nonostante gravemente malato, si era visto revocare dall’Ufficio di presidenza del Senato il vitalizio a cui aveva diritto, a causa della condanna definitiva a 3 anni e 11 mesi pronunciata dalla Corte di Cassazione nell’ottobre 2018 per induzione indebita, nell’inchiesta sulla cosiddetta Sanitopoli abruzzese, che a luglio del 2008 gli costò anche l’arresto. Buona parte delle accuse allora mosse all’ex segretario del Psi si rivelarono infondate, su tutte la più infamante: associazione a delinquere. Venuta meno quella, assieme alle accuse di corruzione e falso, anche l’accusa di induzione indebita, secondo i suoi legali, avrebbe dovuto sgretolarsi. Parere non condiviso dalla Cassazione, che aveva ha deciso di confermare la condanna. Del Turco avrebbe voluto affrontare una nuova sfida giudiziaria: la revisione del processo. Ma le sue condizioni di salute non lo consentirono: era malato di cancro, di Parkinson e Alzheimer. Soprattutto era stato scartato dai poteri forti.
Il 25 agosto è stato il 124° anniversario della morte di Nietzsche, che ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama intellettuale occidentale, con idee che continuano a stimolare il pensiero critico e a sfidare le convenzioni sociali e morali. “Così parlò Zarathustra” rimane un’opera fondamentale per chiunque voglia esplorare le profondità della condizione umana e le possibilità della nostra esistenza. In un mondo in continua trasformazione, le sue parole risuonano ancora, invitandoci a diventare ciò che siamo veramente. Non è solo un trattato filosofico, ma anche un poema epico, un racconto profetico, e una meditazione esistenziale. Nietzsche, attraverso la figura di Zarathustra, un profeta ispirato al fondatore del mazdeismo, Zoroastro, esplora temi fondamentali come la volontà di potenza, la morte di Dio, e la possibilità di un nuovo tipo di umanità, il “superuomo”. Il tema centrale dell’opera è la ribellione contro la cultura e la morale dominante. Zarathustra incarna il rifiuto di un mondo governato dalla mediocrità e dalla debolezza, promuovendo invece una visione della vita come una forza indomabile, dove la volontà è lo strumento principale di affermazione di sé. E questo le ombre oscure che dominano il mondo lo sanno e sanno che occorre spezzare la volontà per indurci alla ubbidienza. E questo presentando nel mondo continue avversità che fiacchino coraggio e disciplina. Il concetto di “superuomo” può essere interpretato in vari modi nell’odierno contesto sociale. Se da un lato può rappresentare un’aspirazione alla realizzazione personale e all’autodeterminazione, dall’altro può essere visto come un avvertimento contro il pericolo dell’egocentrismo e dell’isolamento morale che possono derivare dall’eccessiva enfasi sulla volontà individuale. E quest’ultima cosa il potere oscuro vuole che sembri.
In un mondo sempre più globalizzato e interconnesso, la tensione tra l’individuo e la collettività è un tema di crescente importanza che i dominatori non vogliono sia presente nel pensiero corrente. L’idea dell’ ”eterno ritorno”, che suggerisce la possibilità che tutto si ripeta infinitamente, può essere vista come una metafora della condizione moderna, in cui la storia sembra spesso ripetersi, e le vecchie sfide si ripresentano sotto nuove forme. Questo concetto spinge a riflettere sul significato delle nostre azioni e sulle scelte che facciamo, sapendo che potrebbero avere un peso eterno. Per questo i potenti fanno di tutto per cercarlo. Le trasformazioni prodotte dal largo utilizzo e diffusione della tecnologia conducono verso forme di alterazione sempre più sofisticate, con la conseguente e quasi naturale sostituzione dell’uomo con qualcosa di artificiale. Da qui deriva anche una progressiva e massiccia trasformazione della società, la cui prima e pericolosa conseguenza sembra essere proprio una ridefinizione dell’umano, concepita come una vera e propria ristrutturazione, che investe tutte le sfere dell’essere, a partire dal livello biologico. La lezione che possiamo apprendere dall’antropologia filosofica consiste nell’ammettere che se vogliamo attraversare il complesso fenomeno della disumanità non basterà ripartire dalle radici delle scienze sperimentali che offrono una spiegazione dell’umano, ma sarà altresì necessario ricorrere e convocare aspetti che ineriscono la sfera morale, ma per certi versi anche religiosa.
Considerando come risorsa antropologica fondamentale la peculiare capacità dell’umano di distanziarsi da tutto e da ciascuno, l’essere umano si specchia gli negli altri sia che si tratti dei suoi simili che dell’animale, nella misura in cui, spiega Plessner: «Ego e l’alter ego trovano il proprio limite l’uno nell’altro». Nietzsche affida l’annuncio della “morte di Dio” (ovvero della fine di tutte le certezze) al profeta Zaratustra che sfida, con la sua lanterna accesa in pieno giorno, la folla che sulla piazza del mercato è in attesa del funambolo, gridando “Cerco l’uomo!”, proprio come Diogene il Cinico 14 secoli prima. Mi sembra un’immagine efficace e profetica per dire dov’è l’uomo oggi. Sono finite le certezze e, per questo, l’uomo è al tempo stesso uno che deve oltrepassare l’esistente (ma solo il profeta se ne rende conto), oppure uno che facilmente cade in un vuoto e nello stordimento. Ed ecco come si diventa massa, come il centro di tutto diventa il mercato e l’attesa non è più di un Messia, ma di un funambolo. La storia ci insegna che ogni svolta è complessa e lenta e va letta cautamente. Per questo, mi sembra anzitutto importante cogliere il contesto più ampio in cui si sviluppano post-umanesimo e trans-umanesimo e guardarlo in tutta la sua problematicità, ma anche in tutte le prospettive che si possono intravedere nella misura in cui – lasciandoci interpellare! – non ci lasciamo impaurire, ma comprendiamo a quale bisogno di fondo rimandano e quali vie altre sono possibili rispetto all’attesa di un funambolo.

***
Il termine “transumanesimo” indica che l’uomo, così come oggi lo conosciamo, con le sue fragilità e i suoi limiti, è ormai prossimo a una trasformazione radicale che, grazie al progresso scientifico, lo condurrà nel giro di alcuni decenni a trasformarsi in una nuova condizione, oltre l’umano. La condizione postumana rappresenterebbe l’esito dell’evoluzione della nostra specie: una metamorfosi resa possibile dall’alleanza tra una conoscenza scientifica sempre più capace di penetrare i misteri della natura e un’abilità tecnico-manipolativa sempre più sofisticata. Un’umanità infinitamente più intelligente, non più vulnerabile, più longeva, più ricca, dotata di capacità sensoriali estese e di una fisicità potenziata. Un’umanità irriconoscibile e oggi inimmaginabile, ma anche, proprio per questo, se così accadesse, non più umana. Ciò che combattiamo, con intelligenza e perseveranza, non sono i nostri limiti reali, che ci rendono uomini, ma piuttosto i nostri limiti presunti. Un po’ come accade nello sport, dove la sfida con se stessi e con i propri limiti è pane quotidiano: ciò a cui lo sportivo mira non è superare i limiti del suo corpo biologico, ma esprimere fino in fondo le sue autentiche potenzialità. Se il superamento del limite, di ogni limite, fosse il fine della pratica sportiva, allora lo sport migliore sarebbe quello in cui ogni potenziamento bio-tecnologico (doping, protesi) sarebbe non solo lecito, ma dovuto. E invece, in quel superamento esasperato del limite, noi avvertiamo che qualcosa di prezioso è stato sciupato e che il senso della pratica sportiva è stato violentato. Per essere autenticamente umano, ogni desiderio deve mantenere l’equilibrio tra il tecnicamente possibile e l’umanamente sensato. Per farlo è però necessario porre nuovamente al centro la questione antropologica, chiedendoci non tanto come andare oltre i limiti dell’umano, quanto piuttosto che cosa rende autenticamente umana la nostra esistenza.
“Nella tana del lupo”, libro di Gabriele Tupini, è un’opera che esplora il profondo viaggio psicologico dell’umanità verso la consapevolezza e la liberazione dalla sofferenza. Con un approccio chiaro e accessibile, l’autore si propone di decifrare i passaggi tradizionalmente criptici dell’opera alchemica, una metafora antica che rappresenta la trasformazione interiore e spirituale. Il libro si distingue per la sua capacità di rendere comprensibili concetti complessi, spesso avvolti in un linguaggio esoterico. Tupini utilizza un linguaggio semplice e diretto, senza rinunciare alla profondità delle riflessioni proposte. Ogni capitolo rappresenta un passaggio essenziale del percorso alchemico, interpretato come un cammino verso la conoscenza di sé e la liberazione dalle catene dell’ego e delle illusioni. Un elemento centrale del libro è la sottolineatura dell’importanza della consapevolezza come strumento per eliminare la sofferenza. Ecco allora il primo passo da compiere: aprire gli occhi e cercare in ogni circostanza di essere consapevoli. Ma l’uomo di oggi si nutre solo di uccisione e violenza come ci dice senza pietà alcuna Gianni Canova, attualmente rettore e professore ordinario di Storia e critica del cinema presso l’Università Iulm di Milano, presidente della Giuria internazionale Venezia Opera Prima “Luigi De Laurentiis” nell’imminente 81ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, nel suo romanzo “Palpebre” che rientra nel genere giallo, ma in cui si possono scorgere venature di noir, thriller e horror e anche descrizione di una umanità in totale declino.
Nel racconto il protagonista è Giovanni Vigo (il cui nome ricorda quello del celebre regista Jean Vigo), studioso di letteratura presso l’Università Statale di Milano, interessato in particolare all’analisi del Purgatorio di Dante. Colpito da una giovane donna, Mia, la segue mentre lei si dirige nei bagni universitari con un uomo e diventa testimone dell’omicidio di quest’ultimo, rimanendone sconvolto. Per cercare di capire quanto successo, Giovanni chiede aiuto all’amico Simmel (nome scelto per omaggiare il sociologo e filosofo tedesco Georg Simmel), cronista di nera. Ben presto i due si trovano alle prese con una pericolosa organizzazione e “proiettati in un vero e proprio inferno”. Il tutto si svolge in pochi giorni, ma “Palpebre” riesce ad esplorare le ossessioni del nostro tempo: il sesso, lo sguardo e le trasformazioni dei corpi. Canova ha spiegato come il suo sia un “libro sul male”, scritto per capire cosa spinge l’uomo ad essere attratto da esso. È ambientato nel 2004, anno delle prime decapitazioni filmate da Al Qaida e da ciò sorge spontaneo chiedersi cosa attraesse gli occidentali stessi a prenderne visione in massa. Proprio il protagonista del romanzo avrà a che fare con una pericolosa banda che lucra attraverso la vendita dei cosiddetti “snuff movies” (video che riprendono torture realmente messe in pratica che terminano con la morte delle vittime). Sembrerebbe, dice l’autore, che il pubblico sia allettato da ciò proprio in quanto reale. L’analisi del titolo spiega il tema culturale alla base del romanzo: lo sguardo. “Palpebre”, in quanto lo scrittore si rifà al canto tredicesimo della Divina Commedia, ovvero quello riguardante il girone degli invidiosi, ai quali vengono cucite le palpebre. Invidia e paura, sentimenti che attraversano l’uomo di oggi e lo allontanano sempre più dall’umano.
Nato da una stirpe di artisti, Bach aveva un carattere fumantino ed irascibile, che da giovane lo portò più volte a malmenarsi con altri musicisti e al non essere ligio alle leggi. Con il passare del tempo la sua arroganza non mitigò, anzi si acuì. Conscio delle sue indubbie doti non lesinava pesantissime critiche ai suoi allievi, provocandone il risentimento più acuto e non temeva di portare avanti tempestose liti anche con i nobili e committenti. Secondo voi è possibile che un borioso soggetto come lui potesse firmare i suoi spartiti con la sigla S.D.G. (Soli Deo Gloria), ovvero “Solo alla gloria del signore”? Paradossalmente, come disse Albert Schweitzer suo biografo, decise di bollare così i suoi lavori perché si sentiva tanto grande da potersi permettere di essere modesto. Oggi nessuno fa e si sente così. E torniamo ad Aristotele e al suo messaggio sul valore di un uomo.
Sono un medico e non posso non fare una considerazione sui rischi della medicina nell’epoca del transumanesimo. “Regolerò il tenore di vita per il bene dei malati secondo le mie forze e il mio giudizio, mi asterrò dal recar danno e offesa. Non somministrerò ad alcuno, neppure se richiesto, un farmaco mortale, né suggerirò un tale consiglio; similmente a nessuna donna io darò un medicinale abortivo”. Questo chiede Ippocrate di Kos al medico di giurare; ma oggi teniamo fede a tutto questo? Nel 1976 Jerrold S. Maxmen sosteneva e prevedeva la scomparsa della figura del medico nel ventunesimo secolo. Un’era in cui questa figura sarebbe diventata obsoleta per motivi tecnologici, politici, economici e sociali, un’era in cui si sarebbe instaurato un modello di erogazione delle cure gestito dal computer e da una nuova figura professionale. Già allora si poteva prevedere come le funzioni cliniche e non cliniche dei dottori avrebbero potuto essere gestite da un computer. Per l’autore, con le conoscenze e la tecnologia, già allora a disposizione, la necessità del medico era solo un mito. Maxmen ha fatto previsioni fino al 2025 e buona parte di queste si sono realizzate sia nel campo delle comunicazioni che in quello della tecnologia così come molte in quello biomedico. I mutamenti sono stati sostanziali e rapidi come mai è avvenuto nei secoli precedenti. Possiamo distinguere grossolanamente quattro fasi. Nella prima fase, dall’inizio del novecento fino agli anni ’50, il medico acquisiva finalmente strumenti per curare e guarire malattie acute e infettive. Le vaccinazioni di massa, la scoperta degli antibiotici e di altri farmaci efficaci cambiavano radicalmente le condizioni di salute della popolazione nel mondo occidentale. Il medico aveva un ruolo importante e definito nella società e gestiva la cura in modo autoritario e paternalistico.
La seconda fase fino agli anni ’80 è stata caratterizzata dalla esaltazione delle specializzazioni nate dallo sviluppo della tecnologia prevalentemente diagnostica. Questo ha portato ad una frammentazione delle conoscenze e delle abilità mediche, ha mutato la formazione accademica e ha portato la maggior parte dei medici ad occuparsi in maniera quasi esclusiva di un organo, di un apparato o di una apparecchiatura diagnostica o terapeutica complessa. La terza fase inizia alle soglie del 2000, la tecnologia permette di curare molte malattie e di modificarne la storia naturale. Permette di cambiare la demografia dei continenti. Cambiano le aspettative dei pazienti e la domanda di prestazioni sanitarie. Con la globalizzazione la tecnologia non ha più confini, la figura del medico muta geograficamente solo perché viene disegnata dai sistemi di erogazione delle cure decisi dalla politica. In questa fase la medicina si interessa anche di ambiti estranei alla sua tradizione. Fecondazione assistita, manipolazioni genetiche, chirurgia estetica, protesi meccaniche, trapianti di organi, clonazione, transessualità, sopravvivenza di soggetti ridotti a una vita vegetativa ed eutanasia sono tutte nuove prestazioni mediche. La quarta fase è quella in cui siamo immersi, è quella dell’inflazione di informazioni, quella degli algoritmi, delle piattaforme di rete, dell’IA e della genetica. Del definitivo trionfo della tecnica che uccide l’uomo e la vera medicina come era stata concepita in ogni traduzione e in ogni angolo del mondo.
Si chiama nunchi, o noonchi, sta per “forza/potere dell’occhio” e in Corea divide le persone in due categorie: chi è dotato di quello veloce ha la capacità di decodificare il comportamento delle persone in un istante. Gli altri, quelli insomma dal nunchi lento, devono invece faticare per snellire le proprie interazioni sociali, imparando a leggere tra le righe e a interpretare il linguaggio non verbale. E un medico, rapido o lento.deve possedere questa dote, che un computer con tutte le fisiognomiche del mondo non avrà mai. Riflettiamo su ciò che scrive George Orwell: ” Non è tanto importante restare vivi, quanto restare uomini”. Invece in un mondo finto le falsificazioni sono l’unica cosa che regge. Quella del cinema che celebra la sua stessa morte a Venezia fra glamour e vuoto culturale; quella di un fenomeno musicale, i Maneskin, inventato a suon di soldi e di manager molto furbi e ammanicati, che ora si scopre non esistere e in via di scioglimento. Se la vita è sogno quella di oggi è davvero un brutto sogno.
Facciamo un ultimo esempio che riguarda la Biennale in corso a Venezia, dove il padiglione israeliano resta chiuso in segno di protesta per il non rilascio degli ostaggi a Gaza, mentre una bandiera palestinese si fa largo sull’opera dell’artista franco-africana Josèfa Ntjam alle Belle Arti e il direttore dell’Accademia la lascia sventolare. Il polverone si era alzato prima ancora dell’inaugurazione, quando migliaia di artisti avevano chiesto la chiusura del padiglione israeliano. Nonostante la Biennale avesse ufficialmente dichiarato il diritto dell’artista Ruth Patir di esporre il proprio lavoro nel padiglione predisposto – così come per tutti gli altri padiglioni – il giorno precedente l’inaugurazione l’artista israeliana ha deciso di non aprire le porte del padiglione, perfettamente allestito, fino al giorno della liberazione di tutti gli ostaggi a Gaza e, conseguentemente, di un cessate il fuoco permanente. Invece, tra i padiglioni esterni ai Giardini e all’Arsenale, spicca quello ospitato dall’Accademia di Belle Arti dove, sopra la splendida opera dell’artista franco-africana Josèfa Ntjam, è stata issata una bandiera palestinese. Non si tratta di una scelta dell’artista, poiché l’opera era stata inaugurata – come tutte – ad aprile, mentre gli studenti dell’Accademia hanno issato la bandiera a maggio. E, da allora, non è mai stata tolta.
L’arte, da sempre, è il risultato del contesto (anche) politico dei tempi in cui viene prodotta. Ma quando l’ideologia altrui fa incursione nell’estetica dell’artista, vengono compromessi alcuni capisaldi che, invece, dovrebbero essere garantiti in ogni esperienza estetica. E non importa che la bandiera in questione sia palestinese, israeliana o degli aborigeni australiani: poiché l’appropriazione politica di qualsiasi opera d’arte porta con sé il seme di quel cortocircuito culturale, tipico dei nostri tempi, in cui ogni qual volta ci si appropria o si strumentalizza una bandiera, qualunque essa sia, ci si fa anche portatori di certi valori. Per questo risulta preoccupante che il direttore dell’Accademia di Belle Arti non abbia tolto dall’ateneo la bandiera palestinese. Non certo per i colori dello stendardo esposto, ma perché domani potrebbe esserne issato (o bruciato) un altro, mettendo in discussione – proprio in un luogo come un ateneo – quei valori umani che, invece, dovrebbero preservare uno sguardo aperto sul mondo.