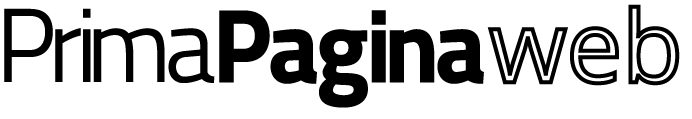Antonio De Meo aveva appena 23 anni e una valigia di sogni. Un ragazzo timido e mansueto che nascondeva dietro i suoi occhiali un brillante studente universitario a Bologna. Giovane uomo con la testa sulle spalle che spendeva il periodo estivo, tra un esame e l’altro, a lavorare come cameriere in un hotel di Villa Rosa, a pochi chilometri da Castel di Lama, il suo paese natale, orgoglioso di non pesare sulle spalle di mamma e papà. In quei giorni di duro lavoro e di mille sacrifici,
Antonio De Meo aveva appena 23 anni e una valigia di sogni. Un ragazzo timido e mansueto che nascondeva dietro i suoi occhiali un brillante studente universitario a Bologna. Giovane uomo con la testa sulle spalle che spendeva il periodo estivo, tra un esame e l’altro, a lavorare come cameriere in un hotel di Villa Rosa, a pochi chilometri da Castel di Lama, il suo paese natale, orgoglioso di non pesare sulle spalle di mamma e papà. In quei giorni di duro lavoro e di mille sacrifici,
nella sua divisa da cameriere amava andare in bici, che si faceva prestare da un addetto dell’hotel appena aveva un po’ di tempo libero. Proprio per quella bicicletta, nella sera del 10 agosto 2009, ha dato la vita. Di fronte ad un chiosco di panini di un luna park un ragazzino rom di appena tredici anni, spalleggiato da altri due appena più grandi, tentò di rubargliela. Antonio reagì prontamente, ma non ebbe il tempo di farlo. Tre pugni al volto fatali, il primo proprio dal più piccolo della banda. Antonio morì così, tra lo stupore e l’immobilità dei tanti presenti. Il gestore del chiosco sentì due colpi contro il suo camioncino, ma continuò a lavorare come se nulla fosse. Un immobilismo inspiegabile rotto dalla volontà di un ragazzino che si decise a chiamare il 118. L’intervento dell’ambulanza fu però vano. La bicicletta venne gettata poco dopo dagli stessi assassini come un ferro vecchio lungo sul ciglio della strada, con lo stesso disprezzo con il quale avevano spezzato una giovane vita senza un perché. Qualcosa però sembrerebbe non tornare. Forse dietro quei violenti colpi potrebbe nascondersi un personaggio dello stesso ambiente, magari già noto, che ha approfittato dell’ ingenuità dei tre adolescenti per sparire nel nulla. Il 23 giugno scorso, presso il Tribunale dei Minori de L’Aquila, avrebbe dovuto tenersi il secondo appello chiesto dagli avvocati dei due ragazzi rom imputabili (il terzo, tredicenne all’epoca dei fatti, è troppo piccolo per essere giudicato) per diminuire ulteriormente la condanna equivalente a otto anni. Una decisione presa per evitare ‘che gli imputati si incattiviscano ulteriormente in carcere’, per salvaguardare il loro futuro. Ma un inatteso sciopero degli avvocati ha inevitabilmente rinviato l’udienza al 15 dicembre. Nell’ aula vuota, quel giorno, c’era solo Lucia, mamma della vittima, insieme al suo avvocato.
“Otto anni: davvero dura immaginare che una sentenza si possa pronunciare in questo modo. Il mio profondo dolore mi spinge a chiedere il carcere a vita. A distanza di appena due anni potrei rivedere gli assassini di mio figlio a piede libero. Sicuramente lo rimarranno fino alla prossima udienza di dicembre, come già è stato concesso loro lo scorso Natale. Non posso accettarlo. La possibilità di una riduzione di pena mi induce a pensare che l’unica cosa giusta sia farsi giustizia da soli. Tutto questo è avvilente. La giustizia italiana li difende e penalizza noi, che non ci siamo sentiti tutelati allora e ancora di più oggi. Una angoscia che mi ha spinto a scrivere una lettera al Ministro Alfano per chiedergli perché la legge non faccia nulla per tutelare noi e i nostri figli. In questo momento sento di parlare a nome di tutte le mamme che hanno vissuto una tragedia di questa grandezza. Penso in particolare alla mamma di Emanuele Fadani, ucciso in circostanze molto simili a quelle di mio figlio, solo tre mesi dopo, da tre rom della stessa famiglia dei tre assassini minorenni. Tutti accomunati da una cultura dedita alla violenza. Io e la mia famiglia non ci sentiamo per nulla ottimisti, lo confesso. Con quello che abbiamo visto fino adesso, si veda il caso Fadani, siamo profondamente sfiduciati. Sono i giudici che non applicano le pene secondo la legge non scritta dello scaricabarile. Muore la speranza di credere nella giustizia”.