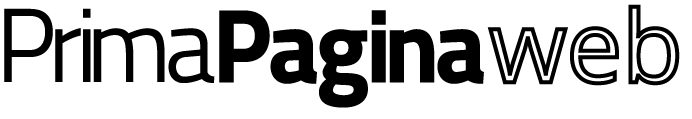Rubrica di critica cinematografica a cura di Carlo Di Stanislao
La distinzione tra passato, presente e futuro è solo un’illusione ostinatamente persistente.
Albert Einstein
Nonostante le cupe atmosfere da terreo, eterno inverno, The Crow uscì in sala nel maggio del 1994. Il film diventò immediatamente ‘di culto’: celebrava l’amore oltre la morte, la speranza al di là dell’orrore, una vita nottambula. Fu il manifesto – a tinte manichee – del dark anni Novanta, una disperazione androgina, dal volto pitturato a pierrot, con i Cure in sottofondo, i Rage Against the Machine in endovena. A conferire al film – in verità, piuttosto didascalico – un crisma leggendario fu la morte, sul set, di Brandon Lee, tragica incarnazione del protagonista, Eric Draven. Quanto al regista, Alex Proyas, continuò ad approfondire il genere – senza deviare nei dintorni del capolavoro – con Dark City (1998) e Io, Robot (2004). La fonte primaria del film – oltre ai generici arcangeli della decadenza dark, del sulfureo nichilismo, della disperanza – è Il Corvo, il poemetto di Edgar Allan Poe, dal ritmo ipnotico, dai toni enigmatici e tombali, con quell’inquieto gracchiare, Quoth the raven, “Nevermore”.
Il film di Proyas s’intitola The Crow, la poesia di Poe s’intitola The Raven; che differenza c’è tra corvo e corvo? Nella mitologia dei nativi americani, Corvo (tradotto come Raven) è il trickster, il mago degli imbrogli, il co-creatore, abile nell’arte retorica, custode dei segreti del primo giorno, capace nell’assumere ogni foggia, mediatore tra i vivi e i morti, tra i terrestri e i celesti. Il suo ruolo, nell’armamentario leggendario dei nativi, è pari a quello del Coyote. Tuttavia, gens du corbeau, genti del corvo, Crow, sono stati chiamati dai francesi gli Apsaroke, una tribù molto, molto evoluta.
Per capire l’intelligenza del corvo bisogna leggere un libro di Bernd Heinrich, La mente del corvo, edito da Adelphi. Tra Raven e Crow c’è la stessa differenza che passa tra corvo e cornacchia? Non lo so. Cornacchia, cornacula, vuol dire piccolo corvo; per capire il genio della cornacchia devo leggere un aforisma di Kafka (nella gabbia del suo nome, in effetti, è appollaiato un corvo): “Le cornacchie affermano che una sola cornacchia potrebbe distruggere il cielo. Questo è indubbio, ma non prova nulla contro il cielo, poiché i cieli significano appunto: impossibilità di cornacchie”. La Bibbia è piena di corvi: “Dio li nutre” dice di loro Gesù (Lc 12, 24). Di “cornacchie fra il cielo e la terra” parla invece Baruc (6, 53), in modo sinistro: riferendosi agli idoli fasulli, agli “dèi bugiardi” forgiati “da artigiani e da orefici”. Il corvo che vuol farsi dio retrocede in cornacchia, il miraggio di un’aquila, uccello che proclama e non mantiene; il corvo seguace di Dio viene da Lui nutrito. Le cornacchie sono gli uccelli più prossimi alla terra: al posto delle ali, sembrano avere delle zampe, sembrano rospi, gli anfibi del cielo.
Non credo che tra le fonti di The Crow ci sia Crow, il libro più bello e tumultuoso e complesso di Ted Hughes. Uscito per la Faber nel 1970, con la copertina disegnata da Leonard Baskin, è una specie di immane, polifonico, imperfetto poema sulla caduta dell’Occidente. Hughes adotta un linguaggio assertivo, scabro, violento, che mescola i miti dei nativi americani, le bibliche mattanze, i simboli della fiaba britannica. Il poeta giustificò le intenzioni di Crow così: “…è la storia dell’Uomo Occidentale. È la storia della sua sempre più disperata ricerca di sicurezze meccaniche e razionali e simboliche, con cui sostituire la fiducia spirituale nella Natura che ha perso… Quando qualcosa abbandona la Natura o viene abbandonato dalla Natura, perde contatto con il creatore, ed è evoluzionisticamente un vicolo cieco. Da questo punto di vista, la nostra Civiltà è un errore evoluzionistico”.
Il ciclo di Crow inizia con una pistola (“Quando la bocca della pistola fu alzata”), su una pistola finisce (“…mantenne così pulita la sua coscienza che diventò nero/ Più nero/ della pupilla/ di una canna di pistola”). Corvo è Edipo ed è Ulisse, è tirannosauro e King of Carrion (“Il suo palazzo è fatto di teschi./ La sua corona è fatta delle ultime schegge/ del vaso della vita./ Il suo trono è la forca delle ossa, l’ultimo letto di tortura dell’impiccato./ Il suo mantello è il nero dell’ultimo sangue”; cito sempre dalla traduzione di Nicola Gardini, in: Ted Hughes, Poesie, Mondadori, 2008), “era talmente più nero/ dell’ombra della luna/ da avere stelle”. Le due canzoni eschimesi che ispirano il testo sono molto belle; in generale, lo sciamanico Hughes tenta parole rituali nell’era dal rito estratta, disfatta: “L’uomo correva senza faccia sulla terra/ Senza occhi e senza bocca a faccia nuda correva// Sapeva di pestare la pietra della morte/ Sapeva di essere un fantasma nient’altro sapeva”. Difficile riprodurre in italiano l’anatomia della ballata, l’andatura di una lingua tutta tamburi e colpi di selce (“Il grido dell’uomo si fece più affilato. La neve più alta”).
Questa è una storia in cui i corvi sono latori di morte; una storia in cui l’amore si compie nella vendetta e nella fuga. Il poeta – figura ambigua e transfuga, con il becco e le penne finanche intorno alla lingua – non può dare la vita ai morti, non può placare la loro ansia. Traffica con parole pari a un azzardo. Questo è The Crow – Il corvo di Rupert Sanders con protagonista Bill Skarsgård, reboot dell’omonimo film del 1994. La pellicola , nelle sale italiane dal 28 agosto scorso, parte da un deficit importante, che è quello di doversi confrontare con un film che nel corso del tempo è divenuto sempre più materia aerosa nelle menti degli appassionati perché si è man mano allontanato dalla sua definizione audiovisiva per approdare ad un’eternità donatagli dalla tragica morte di Brandon Lee.
Tantissime persone che hanno sentito parlare de Il corvo o sanno cos’è, lo sanno proprio a causa di quel tragico incidente. Quando bisogna confrontarsi con qualcosa che è divenuto altro da sé si perde in partenza, quindi, si è cercato di sfruttare l’immaginario cercando un aggiornamento contemporaneo, anche in virtù di una possibilità di mercato che prevede un momento di grande confusione nei cinecomics. Un marasma in cui ci si può provare ad infilare. Si tratta di un’ipotesi ibrida, ce ne rendiamo conto, ma probabilmente è la migliore per ragionare su un malinteso da entrambi questi fondamentali punti di vista. Sì il film è brutto e non funziona, non è ben pensato, non è ben realizzato e neanche così ben recitato, tanto che viene da chiedersi i motivi dietro la realizzazione di un’operazione del genere, che da anni è in cantiere e da anni viene puntualmente stoppata per motivi vari ed eventuali. C’è una motivazione creativa? Una spinta commerciale? Una scommessa persa da parte di qualcuno che conta, una congiunzione astrale o, peggio, planetaria in stile Hercules, oppure, ancora, un giro di riciclaggio di denaro? Non lo sapremo mai.
Il fumetto originale uscì sul finire degli anni Ottanta, e conservava ancora molte tracce di quel decennio: era una storia cupa e romantica come lo era la musica di Cure e Joy Division, e il look dei personaggi (protagonista in primis) sembrava ispirato a una gita in una discoteca goth. Il film originale del ’94, riprende queste suggestioni estetiche, alle quali aggiunge un set design che molti accostarono al primo Batman di Tim Burton, ma che a noi ha fatto venire in mente a più riprese Blade Runner – e non solo per la quantità di pioggia che cade durante la vicenda. Il Corvo è insomma un film di passaggio, un ponte tra due decenni che riesce a individuare con estrema precisione tutte quelle caratteristiche di continuità tra gli eccessi e le pose degli Eighties e il nichilismo cobainiano del decennio successivo. Persino la colonna sonora è costruita con questo criterio: ci sono Cure, Jesus & Mary Chain e Thrill Kill Kult, ma anche Pantera, Nine Inch Nails e Rage Against the Machine, e il miracolo è che lo stacco temporale non si sente (aiuta che due di queste tre band interpretino cover di pezzi anni Ottanta).
Capita spesso che i film connotati temporalmente assomiglino a capsule temporali cristallizzate in un certo periodo; Il Corvo è invece la testimonianza diretta di un cambio di decennio, di un momento di passaggio, e anche per questo è riuscito già trent’anni fa a parlare a due generazioni contigue ma ragionevolmente diverse. Uno dei segreti mica tanto segreti di Il Corvo è più che altro una cosa della quale non si discute mai a sufficienza: Alex Proyas, che al tempo era appena al suo secondo film dopo aver debuttato anni prima con quella che era quasi un’autoproduzione, era la persona giusta al posto giusto e al momento giusto. Il suo Spirits of the Air, Gremlins of the Clouds era una sciocchezzuola sci-fi con tante idee buffe ma una certa carenza di visione d’insieme. Con Il Corvo, anche grazie a una sceneggiatura che si appoggia al fumetto senza snaturarlo ma semplificandolo dove serve, Proyas trova (già) la sua dimensione. Che è poi quella onirica: Il Corvo è un film di inquadrature sbilenche, angoli impossibili, movimenti di macchina volti a disorientare e spiazzare. A tratti è ai confini con l’espressionismo, e quest’estetica da sogno alcolico si accompagna alla perfezione a una sceneggiatura che procede per strappi e scossoni, salti temporali in avanti e all’indietro, continui cambi di punti di vista e anche scarti di tono.
Il rebot non ha niente del genere. Si tratta in sostanza di un rape & revenge nel quale la revenge è a carico di una terza persona e non della vittima del rape, e questa terza persona passa un’ora e mezza a sfogarsi contro chi l’ha ammazzato. Non ci sono mai veri dubbi sul successo della sua missione di vendetta: sembra di vedere Liam Neeson in Io vi troverò, che scena dopo scena elimina interi eserciti di avversari senza sudare. Insomma il protagonista è è un Terminator, o se preferite il mostro di uno slasher anche se ha ragione. Si tratta di un film molto triste e anche di una mera spacconata ipermuscolare di cui non avevamo bisogno. Molto meglio il video, diretto da Derek Soto, del brano The Crow, appena pubblicato dai Life of Agony, dedicato a Brandon Lee e registrato a 30 anni dopo l’uscita dell’iconico film di Proyas e della tragica morte dell’attore.