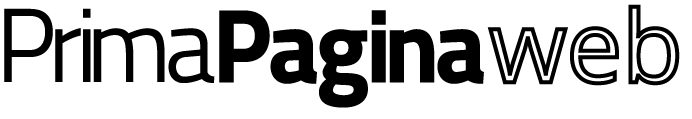DENIS CAVATASSI racconta a RAUL RICCI di PrimaPagina,
DENIS CAVATASSI racconta a RAUL RICCI di PrimaPagina,
In seguito a questo misterioso omicidio vennero arrestati un uomo soprannominato Saa, presunto organizzatore dell’attentato, e il tortoretano Denis Cavatassi, con l’accusa di essere il mandante, come dichiarò lo stesso Saa alla polizia. Le prove a sostegno dell’accusa contro il teramano furono soltanto un bonifico di 700 euro a favore di Saa, suo dipendente, e il fatto che vi fossero state delle telefonate fra questi e Denis. “A giorni saprò la data esatta del processo, che inizierà a settembre del prossimo anno – esordisce-. Le indagini della polizia, in realtà, sin dall’inizio si sono mosse in modo approssimativo: secondo quanto ho avuto modo di capire è venuta a mancare la volontà di ricostruire storia della vittima, di approfondire il suo profilo. I soldi che versai a Saa furono semplicemente un prestito che gli concessi dopo molte pressioni. La mia disponibilità mi si è ritorta contro”. “Ricordo – prosegue Cavatassi – che il giorno dopo in cui Luciano venne ucciso con quattro colpi di pistola, andai al comando di polizia di Phi Phi per cercare di capire cosa fosse successo, con la speranza, magari, di essere utile alle indagini. Non mi sarei mai immaginato di finire insieme agli altri due soci che erano con me come potenziale sospetto. Del fatto che fosse stato versato del denaro ricordo di averlo subito reso noto agli investigatori, nel momento in cui mi domandarono come mai dai tabulati telefonici risultasse che la vittima, poco prima di essere freddata da due killer in moto – tuttora a piede libero – avesse ricevuto una mia telefonata fatta con un cellulare di un nostro dipendente in ferie. Gli investigatori si soffermarono da subito solo ed esclusivamente sulla pista del business, ascoltando alcune testimonianze di soci in affari della vittima presenti in obitorio”. Una situazione paradossale, a tratti kafkiana, venire accusati di un reato terribile, sentendosi impotenti di fronte all’onda d’urto degli eventi. “Da semplice sospettato a unico colpevole il passo fu breve. Nessuna investigazione concreta, nessuna perquisizione che potesse testimoniare una mia qualsivoglia colpevolezza. Penso al semplice fatto che non presero il mio computer per controllare la posta, o perquisirono la mia camera, interrogarono mia moglie o lo staff del mio ristorante. Nulla che potesse dimostrare se c’erano problemi tra me e la vittima. Si disinteressarono completamente di verificare la mia fedina penale, nonché il mio carattere – a detta di tutti – mansueto e rispettoso. Vivo in Thailandia da tre anni e lì – non è un segreto – la polizia ha un potere molto forte, e non ha bisogno come in Italia di un mandato per poter intervenire. Se vogliono arrestarti lo fanno e basta, magari in tempi record per poter far bella figura agli occhi dell’opinione pubblica e passare la palla alla giustizia ordinaria, dando per scontato che il caso sia chiuso. Basti pensare che in meno di 48 ore sono passato da semplice cittadino a presunto assassino, nell’occhio del ciclone dell’opinione pubblica”. Una dignità, quella di Denis Cavatassi, relegata dietro le sbarre per quattro interminabili mesi, dal 18 marzo al 22 luglio, 126 giorni che hanno rappresentato una prova di sopravvivenza psicologica, oltre che fisica, per un albergatore italiano ritrovatosi a confrontarsi in una lotta impari con l’inferno delle carceri di Phuket. “Ho ancora davanti agli occhi e nelle mie narici le condizioni igieniche assolutamente indegne di quel luogo: una vergogna almeno agli occhi di un occidentale. Ricordo la sveglia alle 6.30, che ci facevano rimanere in cella dalle 16.00 circa alle 7.00. Una eternità, in attesa della campanella che annunciava l’ora d’aria nel cortile interno. Qui dovevamo stare accovacciati fino a che le guardie non contano tutti i detenuti, spesso sotto un sole cocente. Nella cella con me eravamo rinchiusi in circa 200, in meno di 160 metri quadri. All’inizio, appena arrivato, mi buttarono lì dentro senza che nessuno mi dicesse nulla, senza sapere dove e come potersi sistemare, senza rendersi minimamente conto di una situazione ai limiti del disumano. Ricordo di aver subito riconosciuto un gruppetto di stranieri ammucchiati in un angolo. Istintivamente mi sono diretto verso di loro, con la speranza di parlare perlomeno un po’ di inglese e non il thai, unica lingua parlata da tutte le guardie. Le rigidissime regole interne ci obbligavano a rispettare determinati cerimoniali scanditi sempre dal suono della campana: dopo il misero pasto serale dovevamo recitare una preghiera a Bhudda e poi una al re, per poi preparare quelli che non possono nemmeno lontanamente essere definiti ‘letti’: una pila di quattro o cinque coperte cucite insieme per uno spessore di 3 cm circa. All’inizio, ricordo che mi sistemai in mezzo ad altri, ritrovandomi a dormire di traverso perché non c’era spazio sufficiente. Una tortura che mi ha impedito di riposare per gran parte del tempo. Per non parlare delle altre gravi carenze: ho visto detenuti con evidenti problemi fisici – malattie della pelle su tutti – abbandonati a loro stessi per mancanza di personale medico e medicine all’interno della struttura carceraria. Gli unici due bagni aperti presenti all’interno della camerata, oltre che negarti qualsiasi forma di intimità, erano riprovevoli: la doccia si poteva fare in un’area apposita, insieme ad altre centinaia di detenuti. Per potersi lavare, ognuno usava dei grossi recipienti. Ricordo che noi stranieri, che non potevamo lavorare come i locali ‘thai’, venivamo mandati in uno spazio di 800 metri quadri sporco dappertutto, dove anche sedersi era proibitivo. In fin dei conti, però, eravamo pur sempre dei privilegiati, visto che le guardie avevano nei nostri riguardi un atteggiamento ben più rispettoso che verso i connazionali, che in alcuni casi, se scoperti con droga o con cellulari, venivano bastonati davanti a tutti e incatenati alle caviglie per un periodo di tre mesi”. La voce di Denis viene assorbita in un silenzio divenuto pesante, chiudendosi in se stessa per qualche secondo, fino a riemergere in una riflessione sincera, amara. “Mi rendo conto solo ora che il destino possa riservarti davvero delle esperienze che vanno ben oltre l’immaginazione. Prima di vivere tutto questo non avevo mai riflettuto a fondo sul concetto di giustizia e di punizione, o su come spesso si possa essere troppo facilmente giustizialisti di fronte quello che potrebbe essere anche un errore giudiziario. In questi mesi di inferno ho acquisito la consapevolezza che l’essere umano è dotato della capacità di sopravvivenza molto forte. Per non impazzire, mi sono rifugiato nei libri, nella ricerca di un barlume di calore sociale. Un distinto signore inglese, rinchiuso lì da tre anni, mi ha aiutato con il potere della conversazione a superare momenti davvero critici. Dal momento in cui mi hanno messo le manette, posso dire di aver sentito morire una parte di me, come se fossi entrato improvvisamente nei panni di un’altra persona. L’istinto di autoconservazione ha acuito, però, con il passare del tempo, le mie capacità intellettive, predisponendomi alla sopravvivenza pura. Il pensiero costante di mia moglie, sposata appena 4 mesi prima dell’ arresto, e soprattutto la voglia di abbracciare la mia piccola Asia, nata il 15 giugno, poco più di un mese prima della mia scarcerazione, mi hanno donato la forza di affrontare l’ultimo, logorante periodo. L’amore mi ha salvato e, sono certo, mi darà la forza di combattere nel momento in cui avrà inizio il processo”.